Maurilio Lovatti
Livio Labor e le ACLI. La presidenza di Labor dal 1962 al 1969
Livio Labor nasce a Leopoli (allora in Galizia, oggi in Ucraina) il 1° luglio 1918 da Marcello, medico chirurgo, e da Elsa Reiss. Il padre era ufficiale medico dell'esercito austriaco. Nel 1934 la madre muore, dopo lunga e dolorosa malattia. Fino al 1936 Livio vive fra Trieste e Pola, dove frequenta il liceo; si trasferisce quindi a Roma per iscriversi alla facoltà di medicina, che abbandona, dopo un solo anno, per quella di filosofia presso l'Università Cattolica di Milano, dove si laurea con una tesi sulla perfezione della natura umana. Il padre (socialista ed ebreo, che nel 1914 si era convertito alla fede cattolica e che nel 1938 fu ordinato sacerdote) esercitò una grande influenza sulla formazione e la personalità di Livio. Dal 1938 al 1956 Livio Labor fa parte della Compagnia di San Paolo, istituto religioso per laici fondato dal cardinale Andrea Ferrari (arcivescovo di Milano dal 1894 al 1921). I membri della Compagnia erano tenuti ad una rigorosa formazione spirituale e all'impegno sociale. Nel 1944 la casa della Compagnia, in via Mercalli, è oggetto di un blitz delle SS naziste, e Livio Labor riesce a sfuggire per un soffio all'arresto.
Nel 1948 si trasferisce a Roma, dove lavora nella Sezione studi dell'ICAS (Istituto Cattolico di attività sociali, organo tecnico dell'Azione Cattolica) come redattore della rivista Orientamenti Sociali. Proprio a Roma, nel congresso nazionale straordinario delle ACLI del settembre 1948, decide di impegnarsi attivamente nel movimento aclista. Nel 1950 torna a Milano e opere instancabilmente nelle ACLI del capoluogo lombardo, di cui diviene vicepresidente provinciale. Dopo il 6° Congresso nazionale (Firenze, novembre 1957) diviene vicepresidente nazionale delle ACLI, con Dino Penazzato presidente nazionale.
Il congresso nazionale di Bari (1961)
Il dibattito precongressuale è caratterizzato da un aspro confronto tra la componente guidata da Labor che diffonde le sue idee e la sua proposta attraverso la rivista Moc (Movimento Operaio Cristiano) e che raccoglierà la maggioranza dei consensi tra i delegati al congresso e la maggioranza uscente di Penazzato, Piazzi e del gruppo dei parlamentari. La posizione del gruppo guidato da Labor è già interamente definita a settembre del 1961: “Saper scegliere nell'oggi significa rifiutare ogni atteggiamento passivo di fronte ai problemi quotidiani, ogni posizione chiusa, isolata o protestataria; significa vigilanza nei confronti di realtà e centri di potere esterni. Ma esige altresì piena assunzione di responsabilità nell'esercizio di una funzione di stimolo e di orientamento di fronte ai lavoratori e alla società, e nel mondo cattolico. Preoccuparsi del domani equivale a mantenere e far crescere, pur nel legame vivo con le lotte di ogni giorno, un impegno culturale a vasto respiro […] Un simile impegno assegna alle ACLI anche una precisa e insostituibile «funzione di riserva» […] comunque distinta dalle vicende spicciole della realtà politica e partitica, economica e sindacale. In tal modo queste vicende non potranno mai soffocare né circoscrivere la potenzialità rinnovatrice del movimento.” («Moc», settembre 1961, Supplemento, pp. 4-5). Nell'ambito di questa concezione delle ACLI, la minoranza insiste in più occasioni, anche in interventi su periodici locali delle varie province, nel lamentare una perdita di “peso” e di influenza politica e sociale del movimento aclista nell'ultimo biennio rispetto al passato e nell'accusare la presidenza Piazzi di essersi limitata sostanzialmente all'ordinaria amministrazione. In più occasioni, nella rubrica Tribuna precongressuale di Azione sociale, vari esponenti della maggioranza rispondono polemicamente ritenendo ingenerose e non giustificate tali accuse, rimarcando anche come la minoranza non abbia fornito indicazioni di alternative concrete e praticabili. Risponde a tutti per la minoranza Domenico Rosati, affermando che il calo del “peso” del movimento non riguarda la quantità di iniziative, corsi e convegni sui singoli temi, ma la capacità di incidere con le proprie prese di posizione sul quadro economico, sociale e politico del Paese. Ricorda anche proposte concrete della minoranza mai attuate, come ad esempio quella relativa ad una campagna nazionale contro il fascismo avanzata durante l'estate dell'anno precedente, in relazione alle proteste popolari contro il governo Tambroni, e pone una significativa domanda alla presidenza: “in passato abbiamo più volte affrontato il problema del socialismo, poi ci siamo improvvisamente fermati. Perché?” (AS, 19 novembre 1961, p. 11). Quando l'8 dicembre 1961 si aprono a Bari i lavori dell'ottavo congresso nazionale delle ACLI, tra le centinaia di delegati presenti vi è grandissima incertezza sui possibili esiti. L'elezione nei congressi regionali dei rispettivi presidenti, in quanto tali membri del consiglio nazionale, si era conclusa 11 contro 10 a favore della maggioranza uscente di Piazzi, mentre per quanto riguarda l'elezione dei 40 consiglieri in congresso, il metodo del panachage (i candidati delle due liste venivano elencati assieme in ordine alfabetico, e i delegati potevano esprimere fino a 30 preferenze) non consentiva previsioni certe sui risultati. La relazione introduttiva di Piazzi è cauta ed istituzionale, senza particolari novità rispetto alla linea tradizionale. Nonostante si fosse alla vigilia dell'importantissimo congresso nazionale DC di Napoli, l'accenno all'apertura a sinistra è breve e prudentissimo, laddove afferma che le ACLI guardano “con particolare attenzione ai fermenti autonomistici che si agitano in seno al mondo socialista e che sono anche sfociati in notevoli manifestazioni ufficiali sia nel campo sindacale sia in sede politico-partitica.” (AS, 17-24 dicembre 1961) Dopo un serrato dibattito, il congresso si conclude in modo apparentemente unitario. Nella mozione politica finale, proposta dalla presidenza uscente e approvata all'unanimità dai delegati, si afferma la continuità con la linea seguita dal movimento: “Sul piano politico, il Congresso conferma gli indirizzi espressi nelle precedenti mozioni congressuali; ritiene che essi possono essere approfonditi e svolti, non abbandonati o innovati, perché rispondono alle indeclinabili responsabilità delle ACLI ...”. Con l'unica concessione significativa alla minoranza, subito dopo: “La funzione politica, esercitata dal movimento, in quanto tale, ha titolo di priorità sulle forme indirette di presenza e di influenza; essa si esprime in piena autonomia […] appartiene al movimento per la sua stessa natura, ed è pertanto, nella sua sostanza, indeclinabile.” (Mozione politica dell'VIII congresso nazionale, in M. C. Sermanni, Le ACLI. Dal ruolo formativo all'impegno sindacale, Dehoniane, Napoli 1978, pp. 443-44) Molto sfumata e prudente è anche l'adesione alla prospettiva di centro sinistra, laddove si raccomanda che le ACLI agevolino “nella prudente evoluzione dei rapporti tra le forze politiche, le possibilità operative di una coraggiosa e lungimirante politica di sviluppo democratico e di progresso sociale” che contribuisca ad isolare “le forze totalitarie, rafforzando così incisivamente l'inderogabile lotta contro il comunismo.” (Ivi, p. 446)
La votazione per eleggere il consiglio nazionale vede alternarsi ai primi posti esponenti della maggioranza uscente e della minoranza (i più preferenziati, nell'ordine, sono: Pozzar, Penazzato, Labor, Storti e Piazzi), ma a conti fatti si assiste ad un capovolgimento di misura della maggioranza, poiché gli eletti della lista capeggiata da Labor sono 23 (a cui vanno aggiunti la delegata femminile e il delegato di GA) contro 17 della lista di Piazzi. Durante il congresso il quotidiano di Roma Il Tempo attacca ripetutamente le ACLI, affermando che la relazione di Piazzi è inspirata alle tesi economiche del PSI, che “i delegati delle ACLI più a sinistra della CISL vogliono l'unità sindacale coi comunisti” e che il congresso si è concluso “all'insegna di un acceso sinistrismo”. Mons. Santo Quadri risponde con un comunicato stampa, affermando che “come Assistente ecclesiastico centrale ha il dovere di dichiarare che il congresso nel suo complesso e in particolare la mozione conclusiva non contengono tesi economico-sociali in contrasto con la dottrina sociale della Chiesa.” (Una precisazione dell'Assistente centrale, in AS, 17-24 dicembre 1961) La conferma della nuova maggioranza avviene il 23 dicembre 1961, quando il consiglio nazionale delle ACLI elegge Livio Labor presidente nazionale con 34 voti, contro i 28 ottenuti da Piazzi ed una scheda bianca (che, a conti fatti, è quella del nuovo presidente). Vittorio Pozzar e Ferdinando Russo sono eletti vicepresidenti e Marino Carboni segretario centrale, ma la minoranza guidata da Penazzato e Piazzi si astiene dalle votazioni e non entra in presidenza. Per la prima volta nella storia delle ACLI, l'esito delle votazioni e il verbale della riunione sono resi pubblici. (AS, 31 dicembre 1961)
Labor dichiara la sua “profonda amarezza” per l'impossibilità pratica di costituire una presidenza unitaria.” Penazzato spiega la decisione di non entrare in presidenza accusando la maggioranza di “proposte troppo disinvolte” e di “non aver obiettivamente consentito una collaborazione unitaria, efficace ed operante, e perciò innanzitutto rispettosa delle posizioni degli altri.” La contrapposizione frontale tra maggioranza e minoranza sarà temporaneamente superata solo sei mesi dopo, nel giugno del 1962 “sull'emozione della morte di Dino Penazzato, il cui estremo desiderio è il superamento delle lacerazioni” (D. Rosati, L'incudine e la croce, Sonda, Torino 1994, p. 135) e in seguito anche alle esortazioni in tal senso di mons. Angelo Dell'Acqua, delle Segreteria di Stato. (Verbale Presidenza, 10 gennaio 1962). Secondo la testimonianza di Domenico Rosati, le ultime parole di Penazzato furono: “Livio, guidami bene le ACLI ed avrai tutte le mie preghiere ed il mio affetto”. Labor “le ascolta come un invito a ricomporre l'unità della gestione, e provvede subito ad integrare gli organi dirigenti con esponenti della minoranza.” (D. Rosati, La profezia laica di Livio Labor: apologia di un cristiano senza paura, ACLI, Roma 1999, p. 46).
Inizia il Concilio Ecumenico Vaticano II
Nel suo primo anno di presidenza (1962), consapevole della scarsa attenzione con cui il movimento ha seguito, tra il 1959 e il 1961, la fase preparatoria del Concilio Vaticano II, Livio Labor cerca con impegno d'invertire la tendenza. All'inizio d'ottobre Azione Sociale riporta il testo di una conversazione del presidente trasmessa dalla radio vaticana nell'imminenza dell'apertura del Concilio: “I lavoratori cristiani delle ACLI hanno vissuto intensamente la fase preparatoria del Concilio ecumenico. In centinaia di riunioni, promosse dalla presidenza centrale e dalle presidenze provinciali del movimento, esse hanno approfondito i grandi temi dell'imminente assise […] Le ACLI hanno tenuto fede, anche così, alla loro essenziale vocazione formativa, sociale e cristiana, favorendo e realizzando, anche negli strati popolari, una acuta percezione del significato non solo sopranaturale e spirituale, ma anche temporale e sociale del Concilio.” (AS, 7 ottobre 1962, p. 5). Labor sottolinea anche l'importanza del dialogo coi “fratelli lontani” e ricorda che le ACLI promuovono e partecipano alla “manifestazione di omaggio dei lavoratori italiani al Papa” che si tiene l'11 ottobre a Roma. La settimana successiva Azione Sociale dedica due pagine all'apertura del Concilio. Padre Gaetano Bonicelli vede nel Concilio l'occasione storica per superare quell'immagine di Dio che si presenta ai poveri e agli sfruttati da “troppi cosiddetti credenti, che amano a parole Dio e tradiscono di fatto i fratelli, che parlano di città eterna e si rifiutano di assumere un ruolo ed una responsabilità nella città degli uomini, pur vivendoci in mezzo e profittando di quello che gli altri realizzano.” (AS, 14 ottobre 1962, p. 3). Nelle settimane successive p. Bonicelli riferirà con puntualità ai lettori del settimanale aclista i lavori della prima sessione conciliare (ottobre-dicembre 1962). Nel frattempo la Lettera agli assistenti aveva pubblicato integralmente la costituzione apostolica Humanis Salutis con cui il Papa spiegava che aveva convocato il Concilio per dare alla Chiesa “la possibilità di contribuire più efficacemente alla soluzione dei problemi dell'età moderna,” (Giovanni XXIII, Humanis salutis, 25 dicembre 1961, in Lettera agli Assistenti, 1962, p. 5-11) il radiomessaggio del Pontefice del 11 settembre e il testo integrale del discorso d'apertura del Concilio. (LA, 1962, pp. 201-206). Nell'imminenza dell'apertura del Concilio, Gioventù Aclista organizza un convegno formativo in quattro giornate sul Concilio, a cui partecipa, oltre a Labor e mons. Quadri, anche mons. Siro Silvestri, vescovo di Foligno. (Relazione generale della presidenza centrale al IX Congresso nazionale, Abete, Roma 1963, p. 156). L'8 ottobre papa Giovanni XXIII nomina perito conciliare mons. Santo Quadri, assistente centrale delle ACLI, e Azione Sociale ne dà notizia con entusiasmo e soddisfazione. (AS, 21 ottobre 1962, p. 3). Già nella fase preparatoria del Concilio, mons. Luigi Civardi, ex assistente centrale dal 1944 al 1955, era stato chiamato dal Papa a far parte della commissione per l'apostolato dei laici (LA, 1962, p. 198) a conferma dell'importanza attribuita alle ACLI. A conclusione della prima sessione conciliare, p. Bonicelli esprime favore ed entusiasmo per gli orientamenti conciari sulla riforma liturgica. (LA, 1963, pp. 13-25).
La Pacem in terris di Giovanni XXIII
L'11 aprile 1963,
giovedì santo, già gravemente ammalato per un tumore allo stomaco, Giovanni
XXIII pubblica la Pacem in terris, quasi un testamento spirituale.
Oltre che per il tema della pace, l'enciclica è molto innovativa anche per
quanto concerne la concezione del potere politico da parte della Chiesa. Per la
prima volta in un enciclica papale, e dunque nel magistero ufficiale della
Chiesa, sono enunciati e apprezzati i valori fondamentali del liberalismo
europeo e della democrazia. Per quanto concerne il principio cardine del
liberalismo, la separazione dei poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario,
Giovanni XXIII scrive:
“La struttura e il funzionamento dei poteri pubblici non possono non essere in
relazione con le situazioni storiche delle rispettive comunità politiche:
situazioni che variano nello spazio e mutano nel tempo. Però riteniamo
rispondente ad esigenze insite nella stessa natura degli uomini l’organizzazione
giuridico-politica della comunità umana, fondata su una conveniente divisione
dei poteri in corrispondenza alle tre specifiche funzioni dell’autorità
pubblica. [...] Ciò costituisce un elemento di garanzia a favore dei cittadini
nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri.” (n.
41)
E per quanto riguarda la democrazia:
“Dalla dignità della persona scaturisce il diritto di prender parte attiva
alla vita pubblica e addurre un apporto personale all’attuazione del bene
comune. L’uomo, come tale, lungi dall’essere l’oggetto e un elemento
passivo nella vita sociale, ne è invece e deve esserne e rimanerne il soggetto,
il fondamento e il fine.” (n. 13).
Oggi tali asserzioni paiono quasi ovvie, ma se si pensa che alcuni regimi del
tempo, né democratici, né liberali, come la Spagna franchista, erano
considerati Stati cattolici da settori del mondo cattolico e dell'episcopato, si
comprende la portata innovativa delle tesi di papa Giovanni.
Le argomentazioni del Pontefice si basano in ultima analisi sulla convinzione
che la pace autentica non può realizzarsi tra gli uomini e le nazioni se non
sul fondamento di un ordine sociale razionale, in cui a tutti gli uomini siano
garantiti i diritti universali e inalienabili per la dignità della persona
umana, e nel quale i poteri pubblici agiscano efficacemente per il bene comune,
eliminando o riducendo le ingiustizie sociali, la povertà, i privilegi, le
disuguaglianze non solo economiche, ma anche culturali.
L'accoglienza delle ACLI alla Pacem in terris è molto buona, non solo e
non tanto per l'enunciazione di principi innovativi nella concezione del potere
degli Stati, quanto perché in essa vi era una conferma della loro visione
dell'azione sociale, di intuizioni ed analisi già in qualche modo presenti nel
movimento, anche se non così chiare e decise come nell'enciclica pontificia. Labor,
in una dichiarazione letta alla televisione di Stato sottolinea
immediatamente gli aspetti del testo giovanneo che più si intersecano con la
proposta politico culturale delle ACLI e ricorda che “nella prima parte
dell'enciclica Pacem in terris, prima di richiamare l'ingresso della
donna nella vita sociale e la crescita dei singoli popoli alla piena dignità
della vita internazionale, viene ricordata l'ascesa economica delle classi
lavoratrici. […] Il Santo Padre riconosce […] che oggi i lavoratori non sono
su posizioni rivendicazionistiche, ma di collaborazione al bene comune, come
soggetti attivi di diritti e doveri, in una società dove tutti sono, come
persone, titolari degli stessi diritti e degli stessi doveri […] Tutti i
cristiani, tutti gli uomini sono chiamati ad uno sforzo di aggiornamento,
d'inventiva, di libertà creatrice per il conseguimento della pace sociale.” (AS,
28 aprile 1963; ripubblicato in A. Scarpitti, C. A. Casula (ed.), Le ACLI e
la Pacem in terris, Aesse, Roma 2003, pp. 141-42).
Il presidente nazionale coglie poi l'occasione per mettere in risalto una tesi
particolarmente significativa per le ACLI, ma anche per tutte le componenti del
mondo cattolico favorevoli ad una collaborazione governativa tra la DC e il PSI
in Italia, che ancora incontra molte difficoltà (si era alla vigilia delle
elezioni politiche del 1963 e il primo governo organico di centro sinistra,
presieduto da Moro, sarà varato solo nel dicembre dello stesso anno). Il
presidente delle ACLI afferma nella sua dichiarazione televisiva:
“Un punto che, come lavoratori cattolici, ci interessa in sommo grado è
quello che riguarda i rapporti con i nostri compagni, legati a schemi e visioni
ideologiche diverse. Il Papa ci invita a rifiutare l'errore, ma anche a cercare
l'errante. E così il traguardo della pace diviene per noi stimolo al dialogo
fraterno con ognuno, con i singoli compagni di lavoro, per cercare insieme, per
offrire un'alternativa globale, valida al desiderio di giustizia, comune a tutti
i lavoratori. […] Sentiamo il dovere di ringraziare il Santo Padre per la
fiducia che mostra nell'impegno dei laici e per la libertà di spirito con cui
invita ad affrontare i problemi temporali ed opinabili, per la responsabilità
che ci viene chiaramente indicata”
Qui Labor coglie e valorizza le aperture del Papa nei confronti dell'autonomia e
responsabilità dei laici cristiani, impegnati in politica o nell'azione
sociale, che si distacca da un modello di Chiesa, come quello propugnato dal
card. Giuseppe Siri o da Luigi Gedda, che attribuisca ai laici un
ruolo prevalentemente esecutivo e attuativo di direttive della gerarchia.
Infatti Giovanni XXIII aveva scritto:
“Non si dovrà però mai confondere l’errore con l’errante, anche quando
si tratta di errore o di conoscenza inadeguata della verità in campo morale
religioso. L’errante è sempre ed anzitutto un essere umano e conserva, in
ogni caso, la sua dignità di persona; e va sempre considerato e trattato come
si conviene a tanta dignità. […] Gli incontri e le intese, nei vari settori
dell’ordine temporale, fra credenti e quanti non credono, o credono in modo
non adeguato, perché aderiscono ad errori, possono essere occasione per
scoprire la verità e per renderle omaggio. Va altresì tenuto presente che non
si possono neppure identificare false dottrine filosofiche sulla natura, l’origine
e il destino dell’universo e dell’uomo, con movimenti storici a finalità
economiche, sociali, culturali e politiche, anche se questi movimenti sono stati
originati da quelle dottrine e da esse hanno tratto e traggono tuttora
ispirazione. […] Inoltre chi può negare che in quei movimenti, nella misura
in cui sono conformi ai dettami della retta ragione e si fanno interpreti delle
giuste aspirazioni della persona umana, vi siano elementi positivi e meritevoli
di approvazione? Pertanto, può verificarsi che un avvicinamento o un incontro
di ordine pratico, ieri ritenuto non opportuno o non fecondo, oggi invece lo sia
o lo possa divenire domani. Decidere se tale momento è arrivato, come pure
stabilire i modi e i gradi dell’eventuale consonanza di attività al
raggiungimento di scopi economici, sociali, culturali, politici, onesti e utili
al vero bene della comunità, sono problemi che si possono risolvere soltanto
con la virtù della prudenza, che è la guida delle virtù che regolano la vita
morale, sia individuale che sociale. Perciò, da parte dei cattolici tale
decisione spetta in primo luogo a coloro che vivono od operano nei settori
specifici della convivenza, in cui quei problemi si pongono, sempre tuttavia in
accordo con i principi del diritto naturale, con la dottrina sociale della
Chiesa e con le direttive della autorità ecclesiastica.” (Giovanni XXIII, Pacem
in terris, nn. 83-85).
Lo stesso numero di Azione Sociale che riporta il testo dell'intervento
televisivo di Labor è quasi interamente dedicato alla Pacem in terris
e ospita, oltre ad una sintesi informativa di Vittorio Pozzar sui contenuti
dell'enciclica, anche vari commenti ed opinioni sulla medesima. Pozzar
afferma che “poche volte nel passato un documento pontificio è stato accolto
con così larga simpatia e così convinta approvazione” (AS, 28 aprile 1963,
p. 3) non solo dai credenti. Padre Aurelio Boschini invece ricorda un
episodio minore, ma “troppo significativo per essere ignorato o sopravvalutato”.
Scrive: “Giovanni XXIII ha voluto firmare la Pacem in terris con la
penna a Lui donata dai lavoratori cristiani in occasione della Mater et
magistra. Gesto paterno, delicato, commovente. E un motivo c'è.
Innanzitutto il Papa ha dichiarato che le due encicliche si completano a
vicenda; poi, ci sembra, perché è proprio il popolo - e le classi lavorative
ne sono la parte più numerosa - che teme maggiormente la guerra e vuole la
pace. Infine perché se la pace è frutto della giustizia è evidente che il
mondo del lavoro ne è il primo interessato. […] La Provvidenza conosce il
cammino della storia; tocca a noi assecondarne il disegno.” (A. Boschini, Proprio
con quella penna, in AS, 28 aprile 1963).
Poche settimane dopo la pubblicazione dell'enciclica, mons. Santo Quadri, in una
relazione rivolta ai quadri dirigenti aclisti, riflettendo sul documento
pontificio, ne sottolinea anche la stretta relazione con l'impegno sociale dei
lavoratori cristiani:
“Il Papa richiama con fermezza i cristiani a superare la frattura tra fede
religiosa e impegni temporali, frattura che è la vera causa dell'inefficienza
dell'azione.” (S. Quadri, relazione al convegno dirigenti aclisti dell'Italia
centrale, 1-2 giugno 1963, in AS, 9 giugno 1963, p. 6.).
Anche l'Assistente centrale delle ACLI sottolinea la distinzione tra l'errore e
l'errante introdotta dal Pontefice, ma ricorda che comunque spetta alla
gerarchia di intervenire anche autoritativamente nella sfera dell’ordine
temporale, quando si tratta di giudicare dell’applicazione da parte dei laici
cristiani dei principi generali ai casi concreti.
Per l'inizio di luglio è organizzato dalla presidenza un incontro di formazione
per sindacalisti, tutto incentrato sulla Pacem in terris. (Circolare
interna del 24 maggio 1963, in ASA, Serie Presidenza, b. 2, fasc. Circolari
1962-63)
Nell'ampio dibattito che si sviluppa all'interno delle ACLI sulla Pacem in
terris, particolarmente significative sono le riflessioni di Gennaro
Acquaviva, che approfondisce il tema della legge naturale nei rapporti con
la fede cristiana, alla luce della tradizionale filosofia tomistica, secondo cui
il “diritto naturale” non cessa di esistere e di essere valido se “entra a
far parte di un ordine superiore; la Grazia infatti non distrugge, ma risana e
perfezione la natura.” (G. Acquaviva, I grandi temi della Pacem in terris,
in «Quadri dirigenti» delle ACLI, 1963, n. 1-2; ripubblicato in A. Scarpitti,
C. A. Casula (ed.), Le ACLI e la Pacem in terris, pp. 151-58, alla p.
153).
Per Acquaviva l'enciclica ha manifestato come la morale e la religione siano “fermenti
vivi, capaci di rinnovare ad ogni livello la storia umana”; e tuttavia ritiene
che vada sottolineato il taglio non integralista del Pontefice, che quando “applica i principi perenni del Cristianesimo alla realtà odierna, sia quando
garbatamente pronuncia valutazioni morali concrete, sia quando con calore umano
e cristiano addita mete che la morale esige siano raggiunte, non pretende di
costruire una scienza politica ed economica e di offrire un programma
prefabbricato per tutte le contingenze della vita; ma da Padre, esperimentato e
saggio […] dà agli uomini, impegnati nelle strutture dell'ordine temporale,
il materiale più prezioso che consentirà […] di adeguarsi sempre meglio alle
esigenze di perfezione insite nella natura umana.” (Ivi, p. 152).
Nonostante i numerosi interventi sulla stampa aclista e la diffusione di sussidi
e materiale informativo, per comprendere l'influsso che l'enciclica ha sul
movimento aclista, può essere utile considerare quanto scrive Domenico Rosati
sulla base della sua diretta esperienza, quando afferma che nelle ACLI
l'enciclica inizialmente “ottenne un'accoglienza comparativamente assai
inferiore a quella che due anni prima, nel 1961, era stata riservata all'altra
grande enciclica giovannea, la Mater et magistra […] anche se il testo del
documento, che il Papa aveva firmato con una penna donatagli proprio dalle ACLI,
venne stampato sul settimanale Azione Sociale e diffuso in tutta
l'organizzazione.” (D. Rosati, Le ACLI al tempo della Pacem in terris,
in A. Scarpitti, C. A. Casula, Le ACLI e la Pacem in terris, pp. 26-36,
alla p. 26).
Ciò è dovuto in parte al fatto ovvio che la Mater et magistra, essendo
totalmente dedicata al magistero sociale della Chiesa, toccava direttamente il
modo di affrontare l'azione sociale del movimento e quindi interessava e
appassionava direttamente gli aclisti che vivevano quotidianamente, nella loro
esperienza, l'esigenza di attuare la dottrina sociale cristiana, mentre il tema
della pace, pur in sé importantissimo, non era vissuto così da vicino.
Inoltre, e sarà un criterio utile anche per valutare la recezione nel breve
periodo delle innovazioni portate dal Concilio, essendo di fatto le ACLI l'unica
organizzazione ecclesiastica la cui vita interna funzionava già sulla base
del metodo democratico a tutti i livelli (dal circolo di paese agli
organi nazionali), era già “abituata” ad assumersi la responsabilità delle
determinazioni e degli orientamenti relativi all'azione sociale, sia pure
tenendo conto dei pareri e dei suggerimenti dei sacerdoti assistenti, e quindi
tende a percepire gli appelli all'autonomia e alla responsabilità dei laici
nelle scelte opinabili nell'ambito delle realtà temporali, sia quelli contenuti
nella Pacem in terris, sia quelli derivanti dalle decisioni conciliari,
come una conferma di una prassi già consolidata, rischiando così di
sottovalutarne la portata innovativa.
Infine va tenuto presente, come si vedrà meglio in seguito, che le ACLI
appoggiavano nella DC la linea di Moro, favorevole al centro sinistra, e
Labor era convinto che la collaborazione con i socialisti avrebbe prodotto
riforme profonde ed efficaci, tanto più il mondo cattolico fosse stato compatto
e coerente al proprio interno; tutto ciò comportava l'interpretazione degli
orientamenti del magistero ecclesiastico in chiave politica, col rischio di non
cogliervi pienamente gli aspetti profetici.
Ricorda ancora Rosati:
“E' dopo il 1966, soprattutto per impulso di Emilio Gabaglio, che nelle
ACLI si diffonderà una coscienza internazionale corrispondente alle esigenze
dei tempi. E sarà in quel momento che la Pacem in terris, nel frattempo
incorporata nell'insegnamento del Concilio, comincerà ad essere testo
frequentato e compagnia fedele per intere generazioni di militanti.” (Ivi, p.
35).
Giovanni Battista Montini e le ACLI
Giovanni XXIII muore il 3
giugno 1963. Il 21 giugno il Conclave elegge il bresciano Giovanni Battista
Montini, che assume il nome di Paolo VI.
Il numero di Azione Sociale del 9 giugno è quasi interamente dedicato
alla morte di papa Giovanni; nella prima pagina, con caratteri molto grandi, è
riportata l'estrema benedizione del Pontefice, che menziona anche le ACLI:
“Benedico la Chiesa, il Sacro Collegio, l'episcopato, il clero, tutti i fedeli
e specialmente gli ammalati, le ACLI e le associazioni cristiane dei lavoratori
di tutto il mondo.”
Nello stesso numero, mons. Santo Quadri ne traccia un significativo e
commosso ricordo, con l'eloquente titolo Il nostro Papa Giovanni.
Passano solo tre settimane e al dolore e al lutto per la morte di papa Giovanni
subentrano la gioia e l'entusiasmo per l'elezione di Paolo VI.
Il numero di Azione Sociale che ne annuncia l'elezione pubblica in
copertina una foto a tutta pagina del nuovo pontefice, con stampate le parole
che aveva rivolto alla presidenza centrale delle ACLI il 21 dicembre 1954, in
occasione della sua partenza per Milano, città delle quale era stato nominato
arcivescovo:
“Se le ACLI cessassero di esistere, alla classe lavoratrice italiana
mancherebbe qualcosa, perché le ACLI sono entrate nel vivo del mondo del lavoro
italiano, tanto da esserne indissolubili.” (AS, 30 giugno 1963).
La gioia è incontenibile: “I lavoratori cristiani esultano […] nel
riconoscere nella nuova Guida della Chiesa, già per questo amata, anche un
amico.” E' riportato anche il testo di un discorso che Montini aveva tenuto
qualche mese prima, nel gennaio del 1963, ai salesiani di Milano, nel quale egli
aveva affermato: “La Chiesa è e vuole essere la Chiesa dei poveri, la Chiesa
dei lavoratori, la Chiesa di coloro che hanno bisogno del pane.”
La settimana successiva mons. Santo Quadri pubblica un ampio scritto Montini e
le ACLI, nel quale cerca di mettere a fuoco il rapporto complesso tra le idee e
gli orientamenti pastorali del nuovo Pontefice e il senso complessivo
dell'azione sociale delle ACLI. Quadri sottolinea come la concezione montiniana
delle questioni sociali manifestata durante l'episcopato milanese sia molto
vicina ai principi generali a cui si ispira il movimento aclista. Secondo
Quadri, mons. Montini aveva spronato
“i dirigenti delle ACLI ad assumere il cristianesimo e la sua dottrina sociale
come bandiera di rinnovamento della società e come forza capace di risolvere i
problemi dei lavoratori. […] Dalle parole di mons. Montini si ricava netta
l'idea che l'assistenza è una cosa necessaria e doverosa, ma tradirebbe sé
stessa se non mirasse a mettere gli assistiti, in questo caso i lavoratori, in
condizioni di muoversi con le proprie forze, sia come singoli, sia come
movimento organizzato.” (S. Quadri, Montini e le ACLI, in AS, 7 luglio
1963.).
L'assistente nazionale delle ACLI ritiene che le ACLI abbiano assolto, e siano
in grado di assolvere, l'importante compito che Montini ha affidato loro:
“Chi scrive può testimoniare che il cuore degli aclisti è sempre pronto al
richiamo del Vangelo e desideroso di testimoniare coi fatti la forza
rinnovatrice del cristianesimo; e se in questi ultimi tempi il Movimento dei
lavoratori cristiani va proponendo con insistenza, nel rispetto dei compiti di
ciascuno, un efficace coordinamento delle forze sociali cristiane, lo fa perché
è convinto di quello spirito di cordiale intesa e comprensione che, il 15
settembre 1949, il Sostituto della Segreteria di Stato indicava come
indispensabile nel campo del comune lavoro.”
Nello stesso tempo mons. Quadri non si nasconde le difficoltà che derivano
dalla peculiare natura delle ACLI, che “Non sono un partito; ma
statutariamente hanno il dovere di «studiare i problemi che interessano i
lavoratori, ricercandone le soluzioni alla luce dei principi sociali cristiani,
per la promozione della classe lavoratrice; di perseguire un'azione di
orientamento dell'opinione pubblica e di stimolo degli organi responsabili della
vita del Paese e di ogni organismo interessante il mondo del lavoro. Non sono un
sindacato; ma devono orientare cristianamente l'azione sindacale.”
La gioia diffusa per l'elezione di Paolo VI si spiega facilmente, tenendo conto
che Egli era considerato, e lo era stato di fatto, una sorta di padre
fondatore delle ACLI. Quando nel giugno del 1944 dopo la liberazione di
Roma, Achille Grandi, fondatore delle ACLI e primo presidente centrale,
diede avvio al processo fondativo del movimento, fu seguito da vicino e
appoggiato da mons. Montini, allora pro-segretario di Stato. Le ACLI nascevano
principalmente come momento formativo e di coordinamento dei lavoratori
cristiani impegnati nel sindacato (che nei primi anni del dopoguerra, fino al
1948, era un sindacato unitario) per preparare i sindacalisti a svolgere anche
in concreto un apostolato d'ambiente nel mondo del lavoro. Montini il 18
settembre 1944 presentò a Pio XII Achille Grandi e Vittorino Veronese,
che sarà presidente dell'AC dal 1946 al 1952, per sottoporre lo statuto del
movimento aclista in via di formazione e incoraggiò il Pontefice ad appoggiare
la soluzione che prevedeva a tutti i livelli della nuova associazione un
assistente ecclesiastico, e non semplicemente un consulente ecclesiastico,
come si era pensato in un primo momento. (D. Rosati, La questione politica
delle ACLI, Dehoniane, Napoli 1975, p. 18; V. Pozzar, Quarant'anni di
ACLI, Ed. Formazione e Lavoro, Roma 1985, p. 23). Non va dimenticato che tra
i fondatori delle ACLI vi era Lodovico Montini, fratello del futuro Pontefice.
In seguito alla scissione sindacale del 1948, le ACLI non rivestono più un
ruolo prevalentemente diretto all'ambito sindacale e, pur mantenendo le altre
funzioni educative, assistenziali e ricreative, si aprono ad un'azione sociale
più generale e politica. In questa trasformazione della missione aclista,
Montini è tenace assertore verso il Pontefice dell'importanza delle ACLI
nell'apostolato e nella formazione cristiana dei lavoratori, a fronte di chi,
anche nella gerarchia ecclesiastica, riteneva ormai superata l'esperienza delle
ACLI e pensava che i loro compiti educativi e formativi potessero essere svolti
dall'AC, mentre le attività assistenziali da altri enti cattolici, come il
Patronato dell'Onarmo.
Negli anni Cinquanta e nei primi anni Sessanta, le ACLI seguono con regolarità
gli interventi e i discorsi di mons. Montini, ne danno ampio risalto sulla
stampa aclista e li utilizzano nei momenti formativi. Tra i tanti esempi,
particolarmente significativa è la pubblicazione del testo integrale di un
ampio articolo di Montini su Azione Sociale del maggio 1958, nel quale
l'arcivescovo di Milano afferma che la dottrina sociale cristiana “non è
l'oppio dei popoli per chi ha bisogno di migliori condizioni di vita; essa non
è lo scudo protettivo per gli egoismi di chi già in abbondanza possiede.”
(G. B. Montini, La questione sociale è ancora aperta, in AS, 18 maggio
1958).
Durante tutto il suo episcopato milanese, Montini ricorda e sottolinea il ruolo
anche ecclesiale delle ACLI e la necessità di mantenere e rafforzare il legame
del movimento con la gerarchia:
“Le Acli sono […] un movimento su cui riposa l'autorità, il consiglio e la
fiducia della Chiesa, su cui riposa la parola della Chiesa; poi potete essere
sicuri che questa vi difenderà, vi seguirà, nobiliterà il vostro lavoro, lo
santificherà…” (G. B. Montini, In occasione della prima visita alla sede
provinciale delle ACLI milanesi, 15 gennaio 1955, in G. B. Montini, Al
mondo del lavoro, Studium, Brescia Roma 1988, p. 41).
La particolare importanza attribuita alle ACLI, una sorta di predilezione, che
caratterizza l'episcopato milanese di Montini non deriva solo dall'affetto verso
il movimento di lavoratori cristiani e dal ruolo svolto quando era alla
Segreteria di Stato, ma si fonda su una visione salda e organica della funzione
della Chiesa e del ruolo dei laici cristiani, che non pare subire mutamenti nel
corso degli anni che precedono l'elezione al pontificato. Infatti Montini è
convinto che il compito della Chiesa sia essenzialmente religioso e morale; essa
infatti:
“dà all'uomo coscienza vera di sé, dà alle cose il loro vero valore in
ordine al bene superiore, dà all'attività umana norme sacre e superiori. Ma la
Chiesa non pretende per sé altre competenze; così che, mentre vincola con le
verità, di cui è depositaria e maestra, gli uomini che la ascoltano, li lascia
liberi di operare in armonia ai principi proclamati nei settori dell'attività
terrestre e secondo i criteri specifici che queste attività possono reclamare.”
(G. B. Montini, Il magistero morale della Chiesa in campo sociale, in AA.
VV., Convegno UCID. Mater et magistra, 18 novembre 1961, GEA,
Milano 1962, p. 25).
Secondo l'arcivescovo di Milano, i lavoratori cattolici, così come peraltro gli
imprenditori o gli altri soggetti economici, possono agire sulla base di
principi razionali desunti autonomamente dalla realtà effettiva, per cercare di
trasformarla e renderla più vicina al bene comune, senza aspettare dalla Chiesa
specifiche direttive, purché tali principi non siano in contrasto con i valori
religiosi e morali insegnati dalla Chiesa stessa.
Pochi mesi dopo la sua
elezione, in un lungo discorso agli aclisti riuniti nel IX congresso
nazionale, il 21 dicembre 1963, Paolo VI ricostruisce con precisione le
ragioni che portarono alla fondazione delle ACLI, nel 1944, e attraverso esse
intende definire meglio la loro ragion d'essere e il loro ruolo nella comunità
ecclesiale e nel mondo del lavoro: “Recuperata la libertà civile, era rinata
la possibilità di riprendere l'attività sociale organizzata […] Fu allora
che si pensò alle ACLI, come organizzazione libera e responsabile, aperta
all'accoglienza delle masse lavoratrici con la massima larghezza possibile,
basata su criteri democratici, non statutariamente collegata con altre
associazioni cattoliche riconosciute, ma non priva della dignità, della forza,
della vocazione del nome cristiano […] Doveva essere […] un organismo nuovo,
semplice, ma di piena espressione morale e sociale, articolato con la compagine
cattolica non solo da un'identità ideologica, come ora si dice, ma altresì
dalla funzione qualificata dell'assistenza ecclesiastica, ma organismo
relativamente autonomo e capace di dare ai lavoratori non soltanto la
possibilità, ma l'idoneità altresì di esprimersi con loro proprie funzioni.
Cioè: l'istituzione delle ACLI fu un grande gesto di bontà e di fiducia della
Chiesa verso i lavoratori. Fu uno sguardo amoroso della Chiesa nel cuore del
nostro popolo, uno sguardo che non durò fatica a scoprirvi impliciti, ma vivi e
preziosi tesori di saggezza, di virtù, di capacità di ordine e di sacrificio,
di talento sociale cristiano; e fu un rischio, che chi è padre, chi è maestro
conosce e affronta in un dato momento, quando vuole che il figlio impari a
camminare da solo, e che il discepolo diventi maturo a ragionare e a fare da
sé.” (Paolo VI, Discorso al IX congresso nazionale delle ACLI, 21
dicembre 1963, in LA, 1964, n. 1, pp. 11-12; anche in AS, 12 gennaio 1964).
Il Papa delimita con accuratezza tre funzioni caratterizzanti il ruolo delle
ACLI ancora attuali e che altre formazioni associative “non potrebbero
esercitare, così bene almeno, come voi invece potete”. In primo luogo la
testimonianza religiosa nel campo sociale, con l'amicizia verso i lavoratori,
con l'esempio, con la solidarietà, col presentare il modello di un uomo “sano,
onesto, vigoroso, e credente e praticante”. Poi, continua il Pontefice, le
ACLI hanno un ruolo determinante nella formazione della coscienza e della
cultura cristiana appropriata alle classi lavoratrici. Il Papa apprezza in
particolare questo aspetto, loda le ACLI per le loro molteplici attività
formative e ricorda con affetto i corsi estivi a cui partecipava quando era
vescovo a Milano. Infine il terzo aspetto è definito da Paolo VI come “promozione
sociale” ed è quello particolarmente sentito, come si vedrà, dalla
presidenza Labor. Il Papa precisa che si tratta della promozione dei legittimi
interessi della classi lavoratrici, che è esercitata con specifica competenza
da sindacalisti e politici, ma che le ACLI possono dispiegare grazie alla loro
conoscenza “dei termini concreti” delle varie questioni, alla loro
competenza dottrinale e giuridica e anche al loro disinteresse rispetto a
possibili vantaggi diretti. Il Papa può così concludere:
Cari aclisti […] voi avete una grande missione da compiere per il vero bene
delle classi lavoratrici, e di riflesso verso la società e verso la Chiesa. […]
Noi vi diciamo, carissimi lavoratori cristiani, la Nostra affezione e la Nostra
fiducia; vi assicuriamo, per quanto è a Noi possibile, il Nostro appoggio
cordiale.” (Ivi, pp. 15-16).
Poche settimane dopo Paolo VI decide di sostituire l'assistente centrale delle
ACLI: mons. Bartolomeo Santo Quadri, che dal 1955 aveva guidato i
sacerdoti assistenti delle ACLI, è nominato vescovo ausiliare di Pinerolo (TO)
il 17 marzo 1964. Nuovo assistente centrale è mons. Cesare Pagani, che
era stato il primo direttore dell'ufficio diocesano milanese per la pastorale
sociale e del mondo del lavoro (1961-63), Nel 1972 Pagani sarà vescovo di
Città di Castello e nel 1981 arcivescovo di Perugia.
Pochi mesi dopo, in un radiomessaggio alle ACLI di Milano, il 1 maggio
1965, Paolo VI ribadisce la sua fiducia nelle ACLI:
“Abbiate coraggio, abbiate fede! Ve lo dice col tutto il cuore chi ha visto
con immensa speranza sorgere la vostra istituzione; ve lo dice chi è stato
vicino alle vostre aspirazioni e ai vostri problemi negli anni indimenticabili
del ministero pastorale in terra ambrosiana; ve lo dice chi sempre continua a
seguirvi con grande affezione e ampia fiducia.” (citato in P. Macchi, Mons.
Montini, le ACLI e il mondo del lavoro, in A. Scarpitti (ed.), Le Acli e
la Chiesa. La crisi del 1971, Aesse, Roma 2002, pp. 56-57).
In questi primi interventi verso le ACLI di Paolo VI da pontefice emerge la tesi
significativa che il ruolo delle ACLI non si esaurisce nell'apostolato e nella
formazione (che in linea puramente ipotetica potrebbero anche essere attuati da
un ramo specializzato dell'Azione Cattolica) ma prevede il momento ineliminabile
dell'azione sociale. Infatti già nel 1959 aveva detto:
“Avete anche un'altra missione, oltre che quella formativa e scolastica,
quella pratica: la classe lavoratrice ha bisogno di alcune progressive
trasformazioni dell'ordine sociale. Avete raggiunto tutto quello che si può
dare alle vostre categorie? No, perché c'è ancora, su vari punti, una grande
distanza tra le classi: distanze economiche, culturali, sociali. Bisogna, nella
concezione giusta della società, che queste distanze si accorcino, e che quindi
chi ha meno venga ad ottenere qualcosa in più e lo ottenga in maniera non
violenta...” (G. B. Montini, All'incontro provinciale delle ACLI milanesi,
28 giugno 1959, in G. B. Montini, Al mondo del lavoro, p. 129).
I primi anni della Presidenza Labor (1962-66)
Durante gli anni della sua Presidenza, Labor si avvale di un numero ristretto ma fidato di valenti collaboratori. Oltre a Vittorio Pozzar, che era dirigente nazionale e membro della presidenza fin dal 1953, il presidente forma una squadra di giovani dirigenti: Marino Carboni, segretario centrale responsabile dell'organizzazione, Geo Brenna, giovane esperto d'economia, a cui viene affidata la responsabilità dell'ufficio studi, Domenico Rosati, responsabile della stampa aclista ed Emilio Gabaglio, anche lui giovanissimo, inizialmente destinato all'ufficio studi per le politiche sociali e che poi seguirà le questioni internazionali.
Fin dai primi anni la gestione Labor si caratterizza per il forte impegno nella formazione. Nel 1962, primo anno di presidenza, sono organizzati nelle varie province ben 179 corsi di formazione che coinvolgono 5462 partecipanti. (Relazione generale della presidenza centrale al IX Congresso nazionale, p. 39). I temi trattati sono sia religiosi (come il Concilio o La pacem in terris), sindacali ed economici (il lavoro domestico, la retribuzione delle lavoratrici) sia politici (le regioni, la nazionalizzazione dell'energia elettrica, il Parlamento, il centro sinistra). Vengono prodotti e diffusi alle province numerosi materiali informativi ed opuscoli su temi specifici, oltre a guide per i militanti e gli iscritti. A livello nazionale la Scuola centrale di formazione nel biennio 1962-63 organizza 7 corsi residenziali per dirigenti, di durata dai 12 ai 16 giorni, e nello stesso periodo l'Ufficio studi promuove 5 convegni nazionali di studio. (Ivi, pp. 47-49). L'impegno straordinario delle ACLI di quegli anni è ben sintetizzato da Domenico Rosati: “Il fulcro della formazione aclista è l'Ufficio centrale di formazione che coordina e alimenta tutta l'attività generale e specifica dei settori. Esso cura particolarmente la «scuola centrale». Sorta nel 1958, la scuola rappresenta, dopo cinque anni di rodaggio, una delle iniziative più interessanti e serie attuate in tale campo nel mondo cattolico. La frequentano quanti aspirano a ricoprire ruoli di responsabilità permanente nei vari settori di attività aclista e si prefigge di dotare le sedi provinciali di personale altamente qualificato sul piano ideologico e specializzato sul piano tecnico. E' qui che nasce la «nuova classe dirigente» delle ACLI.” (D. Rosati, L'incudine e la croce, p. 140).
Oltre al potenziamento della formazione, una seconda linea guida della presidenza Labor è costituita dalla determinazione nel rafforzare e rendere più efficace la possibilità del movimento aclista di esercitare una pressione, un'influenza sulle decisioni politiche, nella consapevolezza che per migliorare le condizioni dei lavoratori siano necessarie profonde trasformazioni sociali ed economiche che solo la politica può realizzare. Questa è una convinzione che Labor aveva maturato fin dagli inizi degli anni Sessanta, quando era ancora in minoranza e fuori dalla presidenza centrale. Già nel 1960 aveva affermato che “uno dei tratti caratteristici delle ACLI […] è quello di essere un gruppo d'influenza ideologica e culturale.” (L. Labor, Le ACLI oggi. Gruppo di influenza ideologica e culturale, «Moc», dicembre 1960, in L. Labor, Scritti e discorsi, vol. 1, pp. 263-67, alla p. 263). L'idea di fondo era che le ACLI potevano proporre alla politica un progetto coerente di trasformazione sociale, non limitandosi solo, attraverso i parlamentari eletti nella DC, ad ottenere singoli provvedimenti legislativi specifici a vantaggio dei lavoratori. Nei primi anni Sessanta questa idea si traduce in un appoggio convinto e determinato alla prospettiva del centro sinistra. Nella relazione introduttiva al IX congresso nazionale delle ACLI Labor è esplicito e riferendosi al congresso di Napoli della DC dell'anno precedente, afferma: “La conclusione cui pervenne il Congresso democristiano fu chiaramente in linea con le richieste dei lavoratori cristiani […] la porta aperta alla collaborazione coi socialisti […] apriva una prospettiva nuova, nel senso di un maggior impegno da parte di tutti e di ciascuno, a meglio chiarire e caratterizzare la propria fisionomia.” (L. Labor, Scritti e discorsi, vol. 1, pp. 332-85, alle pp. 360-61). Che questa valutazione sia comune a tutti gli aclisti è confermato dalle autentiche prolungate ovazioni che accompagnano l'intervento di Aldo Moro, l'ultimo giorno del congresso aclista. Labor nutre grandi aspettative verso il centro sinistra, anche perché apprezza e ritiene importanti per i lavoratori le riforme prospettate, alcune realizzate rapidamente, come la nazionalizzazione dell'energia elettrica e la scuola media unica, altre attuate con molto ritardo, come l'introduzione delle Regioni a statuto ordinario, altre ancora non realizzate per le forti resistenze, come la riforma urbanistica. Tuttavia per Labor l'elemento qualificante del centro sinistra è la programmazione economica. Nella relazione congressuale vi dedica largo spazio, oltre venti pagine, e spiega: “La pianificazione è pertanto prima fatto politico che tecnico. In tal caso non è accettabile se non come occasione di più avanzata democrazia: in quanto capacità cioè di chiamare tutte le classi […] a fissare le mete comuni, nonché i sacrifici necessari ed i vantaggi possibili per tutti. Si tratta in altri termini di sottrarre le scelte fondamentali per il progresso del Paese alla competenza di ristretti gruppi di potere economico […] per farne oggetto della partecipazione e dell'impegno di tutti i cittadini […] il tutto per consentire agli organi del potere politico democratico - articolati su base regionale e locale - di prendere le decisioni finali e di dare gli indirizzi operativi con la sicurezza d'interpretare, nel modo più adeguato, gli interessi della collettività nazionale.” (Ivi, pp. 343-44; la relazione congressuale è pubblicata in un volume a stampa: L. Labor, Il movimento operaio cristiano nella nuova realtà sociale italiana, ACLI, Roma 1963; il capitolo sulla pianificazione democratica è alle pp. 31-52.). Già qualche mese prima, in una circolare interna diretta alle strutture periferiche, aveva affermato: “Tutti i problemi tradizionali della politica economica e sociale dovranno trovare un elemento di giustificazione e di unitaria soluzione nell'attività di pianificazione.” (Circolare del presidente nazionale delle ACLI del 1 febbraio 1963, in ASA, Serie presidenza, b. 2, fasc. Circolari 1962).
Questa visione forte e ottimistica della pianificazione è destinata ad andare rapidamente incontro a delusioni cocenti. Già nell'estate del 1964, con la crisi che precede la formazione del secondo governo Moro, gli obiettivi più ambiziosi del centro sinistra vengono di fatto abbandonati, sia per condizionamenti esterni, come le minacce golpiste legate al piano Solo del generale De Lorenzo e le pressioni del governatore della Banca d'Italia Guido Carli, del ministro Emilio Colombo e degli industriali per una politica economica meno espansiva attraverso le restrizioni creditizie e il blocco salariale, sia per ragioni interne alla DC, dopo che Fanfani aveva sostenuto la non irreversibilità del centro sinistra. La programmazione economica finisce poi per produrre effetti opposti a quelli desiderati: i consumi crescono nei settori trainati dal mercato (come abitazioni, telefonia, televisori, trasporto aereo) anche più dei livelli previsti dal piano, mentre in settori decisivi per trasformare la società (come istruzione, sanità, edilizia pubblica, trasporto ferroviario, bonifiche e opere idrauliche, ecc.) rimangono notevolmente al di sotto degli obiettivi programmati. Per Labor l'entusiasmo iniziale per il centro sinistra si trasforma rapidamente in delusione, mentre cresce nel frattempo la sfiducia verso la DC, sempre meno capace di attuare con coerenza una politica autenticamente riformista. Non va dimenticato che nelle elezioni politiche dell'aprile del 1963, le ACLI avevano sostenuto con forza e convinzione la DC, riuscendo a far eleggere 33 deputati su 48 candidati aclisti, concentrati soprattutto in alcune regioni, come la Lombardia (8 eletti), l'Emilia (5), il Veneto e il Lazio (4), e 4 senatori su 7 candidati. (AS, 24 marzo 1963 per i candidati aclisti; AS 5 maggio 1963 e circolare del 15 maggio 1963, in ASA, Serie presidenza, b. 2, fasc. Circolari 1962-63 per gli eletti).
La delusione e il dissenso delle ACLI per l'orientamento della DC e del governo sono chiaramente espressi da Labor, che intervenendo all'assemblea nazionale della DC di Sorrento (30 ottobre – 3 novembre 1965) non modera le parole e accusa apertamente: “Sul problema della pianificazione - il fatto centrale del nostro futuro civile - il Partito, nella sua linea ufficiale, ha assunto già un atteggiamento giustificazionista di scelte altrui, che non d'invenzione e propulsione.” (L. Labor, relazione all'assemblea nazionale DC, in ASA, Fondo Labor, b. 6, fasc. Assemblea nazionale DC di Sorrento, p. 5). Labor paventa esplicitamente il rischio che la DC assuma un compito di “frenare” le riforme, lasciando ai socialisti il ruolo di “accelerare”, che nel lungo periodo può alienare i consensi dei lavoratori alla DC. Molti anni dopo, riflettendo sulle ragioni del distacco dalla DC a metà degli anni Sessanta, Labor aggiungerà altri elementi e scriverà: “Non ero più iscritto alla DC dal 1966, perché avevano nominato Scelba presidente del Consiglio nazionale. Mi son detto: in questo partito il cui simbolo è un uomo, ministro degli interni, che ha fatto ammazzare dalla Celere 157 lavoratori inermi in occasioni di scioperi ed iniziative sindacali, non ci posso stare. Zitto zitto sono andato via. Ho tra l'altro, quale membro di diritto del Consiglio nazionale della DC, cominciato allora a conoscere la vita morale, i metodi di finanziamento, le ruberie, la disonestà della guida politica dei leader democristiani. Non per acidità, non per astratto amore del laburismo cristiano (che era l'intima aspirazione di Dossetti quando lasciò la politica), ma per motivi di coscienza, me ne sono andato via.” (Intervista a Livio Labor, in AA. VV., Una lunga fedeltà. Per una storia religiosa delle ACLI, Nuova Stampa ed., Milano 1995, pp. 93-113, alla p. 107).
In realtà le difficoltà dei settori più vivaci del mondo cattolico e dell'associazionismo ecclesiale a rapportarsi con la DC non dipendono solo dalla disillusione per le mancate politiche riformatrici del centro sinistra, ma si intrecciano con il cambiamento di prospettiva che gradualmente andava determinandosi con la ricezione e l'interiorizzazione del messaggio conciliare, poiché esso investiva direttamente il rapporto tra fede e politica. Il malessere nel rapportarsi con la DC non è presente solo nelle ACLI, ma anche nell'Azione Cattolica, nella FUCI e in modo meno evidente anche in altre associazioni cattoliche nei tardi anni Sessanta. Come nota acutamente Antonio Acerbi: “Rispetto al Concilio, i laici avevano […] attese e interessi diversi, a secondo della loro collocazione e della loro storia; ma il discrimine più penetrante non era legato alle opzioni teologiche, ma a quelle politico ecclesiastiche […] Ciò su cui maggiormente i cattolici si contrapponevano era l'atteggiamento da assumere verso la DC. Secondo alcuni quest'ultima era l'impedimento maggiore contro un rapporto evangelico fra la Chiesa e la società; all'estremo opposto per altri il sostegno alla DC era una tessera di cattolicità. Il Concilio era tirato di mezzo: chi combatteva il legame fra la Chiesa e la DC, lo faceva in nome dello spirito conciliare, e chi lo difendeva, sotto sotto era dell'opinione che il Vaticano II per certi suoi aspetti era un fattore destabilizzante. Nelle file del partito regnava un certo imbarazzo: da un lato il Concilio aveva ammesso i principi teologico-politici a cui la DC era da sempre ispirata, ma, dall'altro aveva messo in moto una spinta che minacciava di delegittimare il partito. Le prospettive erano due: o l'affermazione delle ragioni politiche della DC, con l'avvio di una esplicita laicizzazione del partito, o una riscoperta, in termini nuovi, della propria radicazione religiosa. […] Ma i responsabili del partito in quegli anni del primo postconcilio scelsero di non scegliere...” (A. Acerbi, La Chiesa italiana dalla conclusione del Concilio alla fine della DC, in A. Acerbi (ed.), La Chiesa e l'Italia. Per una storia dei loro rapporti negli ultimi due secoli, Vita e Pensiero, Milano 2003, pp. 449-520, alla p. 455).
Un terzo elemento caratterizzante dell'impostazione di Labor riguarda la centralità dell'impegno delle ACLI per promuovere e favorire l'unità sindacale dei lavoratori, impegno che le ACLI mantennero fermo per tutti gli anni Sessanta e i primi anni Settanta, ma che procurerà a Labor difficoltà di rapporti e conflitti polemici, sia con la componente comunista della CGIL, perché le ACLI ritenevano l'incompatibilità tra cariche sindacali e mandato parlamentare una importante condizione per facilitare l'unità dei lavoratori, sia con la maggioranza della CISL guidata da Bruno Storti, sempre per la questione dell'incompatibilità, ma anche perché le ACLI attribuivano un ruolo imprescindibile alla base e ai lavoratori non ancora iscritti al sindacato nel processo di unificazione del movimento sindacale italiano, mentre Storti pensava che le decisioni sul processo di unificazione riguardassero in primo luogo gli iscritti alle tre confederazioni. Labor era invece molto in sintonia con la minoranza della CISL, in particolare con Luigi Macario, segretario dei metalmeccanici. Storti e la maggioranza della CISL polemizzano a più riprese con le ACLI, arrivando a considerare le prese di posizione di Labor come una sorta di invasione di campo, al punto che Storti stesso è sonoramente fischiato dai delegati al X congresso nazionale delle ACLI (novembre 1966).
Le principali linee operative della gestione Labor (potenziamento della formazione, impegno politico per trasformare la società e unità sindacale) si radicano tutte in una concezione forte e totalizzante della militanza aclista, con tratti utopici, che Labor aveva elaborato fin dai tempi della rivista della minoranza Moc (movimento operaio cristiano, 1960-61), che corrisponde solo parzialmente alla realtà dei militanti e dirigenti locali aclisti. Scriveva su Moc che la militanza aclista nasce dalla felice sintesi tra la fede religiosa, la spiritualità del lavoro, l'impegno nello studio e nella comprensione delle dinamiche sociali, l'azione sindacale e sociale, che entrano a far parte della “ideologia aclista” che “matura in ogni momento della vita e dell'esperienza dei lavoratori cristiani: nello studio, ma anche nelle battaglie più difficili, che verificano e talvolta impongono di aggiornare l'ideologia, mettendo a nudo deficienze culturali, prima ancora che operative. Non si rischia il posto di lavoro nel nucleo o nel sindacato, nelle battaglie elettorali ed in tante altre occasioni, se dentro di noi non c'è la spinta di idee-forza, verificate, assimilate, direi personalizzate: diventate noi stessi.” (L. Labor, Le ACLI oggi. Gruppo di influenza ideologica e culturale, dicembre 1960, p. 264). Questa stretta connessione tra la spiritualità derivante dall'ispirazione cristiana, la formazione e l'azione sociale sarà un carattere costante delle ACLI di Labor: “Il dirigente aclista va a Dio anche tramite le ACLI, che sono movimento di azione sociale cristiana, non solo di servizi o di formazione, anche se la formazione ha gerarchicamente e ontologicamente la sua preminente importanza; […] La moralità adulta del movimento deve essere tale da mettere in grado i lavoratori e innanzitutto i dirigenti, di realizzare una sintesi tra spiritualità e azione sociale. […] La trasformazione dei lavoratori cristiani in militanti impegnati: questo caratterizza anche l'azione sociale aclista. Il nostro fine essenziale non è una generica elevazione di classe o di gruppo, ma la formazione di un tipo di militante o dirigente capace di essere testimone e guida; di salvarsi salvando e di servire guidando altri lavoratori...” (L. Labor, La spiritualità cristiana del dirigente aclista, in La spiritualità del movimento dei lavoratori cristiani, atti del XIII convegno nazionale degli assistenti ecclesiastici delle ACLI, Firenze 17-21 settembre 1962, ACLI, Roma 1963). Per Labor l'azione sociale delle ACLI fondata su tale concezione della militanza contribuisce oggettivamente al bene della Chiesa nel suo complesso: “La Chiesa interviene solo eccezionalmente nelle scelte temporali opinabili: normalmente lascia libero il laicato di decidere. Ora, se noi abbiamo una spiritualità autenticamente cristiana, se siamo veramente seri, possiamo evitare alla gerarchia il compito di dover intervenire continuamente nella realtà politico sociale del nostro Paese.” (Ivi, p. 461).
Il X congresso nazionale delle ACLI (1966)
La disillusione crescente verso la DC e nei confronti dell'incapacità del centro sinistra di realizzare riforme strutturali nella direzione desiderata dalle ACLI trovano una crescente esternazione nel convegno estivo di Vallombrosa del 1966 e poi pochi mesi dopo nel congresso nazionale di Roma, in un quadro complessivo nel quale la linea politica della DC, egemonizzata dai dorotei del segretario nazionale Mariano Rumor, dirigente aclista negli ormai lontani anni Cinquanta, appare al gruppo dirigente del movimento una forma di moderatismo e di normalizzazione inaccettabile. Nella replica finale alle giornate di studio di Vallombrosa (27-31 agosto 1966) sul tema Il potere economico nella realtà italiana, Labor indica sinteticamente la direzione di sviluppo dell'azione aclista, ribadendo l'obiettivo dell'unità sindacale non vincolata agli equilibri di partito, ma fondata sulla volontà dei lavoratori, il valore della pianificazione democratica e della partecipazione dei lavoratori alla definizione degli obiettivi e delle riforme. Per Labor l'azione politica delle ACLI e più in generale del movimento operaio è essenziale per condizionare il potere economico e indirizzarlo secondo le esigenze della società civile. Il messaggio lanciato alla DC, seppur in forme tutto sommato cordiali e non polemiche, lascia intravvedere una sorta di ultimatum: “Nulla ha da temere la DC, purché sia aperta agli obiettivi, ai metodi, alle soluzioni proposte, in un sereno dibattito, dalle forze sociali ed in particolare da quelle di ispirazione cristiana, per evitare altre canalizzazioni, non so se per rigagnoli o fiumi.” (L. Labor, Relazione conclusiva al convegno di Vallombrosa 1966, in QAS, 1966, n. 3, pp. 541-564, alla p. 562). Labor prende atto che il 78% degli aclisti presenti al convegno sono iscritti alla DC, come risulta da un questionario, ma avverte che questo tradizionale rapporto col partito non può e non deve sminuire il ruolo nell'azione sociale: “Le ACLI ritengono di essere una forza sociale viva di lavoratori e sarebbe perciò vano pretendere da esse solo un atteggiamento di razionalizzazione e giustificazione dell'attuale assetto dei rapporti economici e di potere, giacche le ACLI ritengono che questo assetto non realizzi interamente una democrazia effettiva.” (Ivi, p. 561; la percentuale di aclisti iscritti alla DC è riportata a p. 559).
Il convegno estivo ha un ampia eco sulla stampa nazionale nei primi giorni di settembre. Significativo è il commento del Sole – 24 ore un paio di settimane dopo, che sostiene che gli aclisti “sono quelli di sempre, e seguono la loro linea di azione ispirandosi al contenuto ideologico integralista del primo partito popolare che, rifiutando gli ordinamenti dello Stato liberale, chiamava direttamente il popolo alla sovranità del potere. A noi preme soprattutto mettere in risalto la precisa determinazione del movimento operaio cristiano di sospingere il partito e il sindacato democristiano su posizioni estremiste, di imporre una nuova condotta nelle aziende, di pretendere la partecipazione diretta al controllo della gestione dell'impresa, in barba ai contratti di lavoro. Questo è un traguardo preciso ed anche confessato seppure in mezzo al fumo di tutti gli altri discorsi di contorno.” («Il Sole – 24 ore», 13 settembre 1966). A prescindere dalla falsa affermazione sul rifiuto degli ordinamenti dello Stato liberale, gli industriali comprendono con chiarezza che le posizioni assunte dalle ACLI possono condizionare la DC e la CISL e soprattutto mettere in discussione la linea di politica economica del governo, sostanzialmente moderata e molto prudente nelle riforme, in un quadro di restrizione creditizia e di contenimento salariale giustificato da esigenze congiunturali. Il conflitto latente con la DC esplode pubblicamente durante i lavori del X congresso nazionale delle ACLI, che si svolge a Roma dal 3 al 6 novembre 1966, quando il segretario nazionale della DC Mariano Rumor, che invita gli aclisti a partecipare più attivamente alla vita politica del partito, (M. Rumor, Un partito sensibile ai fermenti sociali, in AS, 20 novembre 1966, p. 20) viene impietosamente e ripetutamente fischiato dai circa mille delegati presenti. Subito dopo Rumor, interviene applauditissimo Ettore Morezzi, presidente delle ACLI torinesi e vicinissimo a Labor, che non nasconde le motivazioni del dissenso aclista: “La nostra preoccupazione nei confronti della DC è dovuta al fatto che un tempo le scelte della DC corrispondevano alle scelte delle nostre coscienze, ora troppo spesso le vediamo coincidere con le scelte dei centri di potere esterni o interni alla DC. Noi abbiamo cercato di combattere questa tendenza in tutti i luoghi dove fosse possibile. Ma sentiamo che il partito ha dei dubbi nell'invertire questa tendenza. […] Questo non è un discorso irresponsabile, credo, on. Rumor, è difficile per noi partecipare in questa situazione alla vita della DC.” (AS, 20 novembre 1966, p. 20). Sulla stessa linea di pensiero anche Emilio Gabaglio, stretto collaboratore di Labor, destinato a entrare nella nuova presidenza che verrà eletta dopo il congresso, che afferma: “[in passato] abbiamo assicurato una copertura a sinistra, veramente popolare alla DC. Le ACLI sono state per molti lavoratori un punto di riferimento per superare lo sconforto di una battaglia politica che spesso sembra tradire le grandi premesse ideali da cui pure era partita. […] La DC potrà ancora aspirare ad essere una componente del futuro partito delle riforme e del progresso solo se saprà impostare un rapporto nuovo con tutte le forze sociali e culturali del Paese che sono di matrice cristiana e innanzitutto con quelle del lavoro. […] Non vale l'appello ad entrare nel partito, che fu lanciato nel 1959 [da Fanfani], se le porte sono sbarrate e le burocrazie, gli interessi fanno muro.” (Ivi, p. 21).
Nella lunghissima relazione introduttiva al congresso, distribuita in un volumetto ai delegati, Labor era stato più prudente, ma nella sostanza aveva manifestato la stessa sfiducia nelle possibilità della DC di prendere la direzione di un autentico processo riformatore; dopo aver ribadito e meglio precisato l'orientamento delle ACLI sull'unità sindacale, sulla pianificazione democratica e sulla partecipazione dei lavoratori, già rese pubbliche nel convegno estivo di Vallombrosa, aveva continuato a pungolare la DC affermando: “Senza nessuna celata volontà di trasformarsi in partito, il movimento dei lavoratori cristiani non considera definitive le esperienze economiche, sociali e politiche in cui opera. Ciò significa che esso guarda ai tempi lunghi della democrazia italiana, il cui assetto politico e sociale non può dirsi definitivamente stabilizzato. Vi sono scelte radicali che oggi sarebbero premature da compiere, ma che domani, forse, saranno necessarie. Siamo aperti a tutte le possibilità, purché positive per la democrazia italiana e coerenti con il nostro essere. Non dobbiamo né vogliamo bruciare nel presente le novità possibili nel futuro, quando neppure si riesce ad intravederne ancora le linee di sviluppo. Ma non dobbiamo lasciarci cogliere impreparati. […] Ma chiedo altresì a tutti gli impegnati [nel partito] di restare, anche rischiando, là dove sono e domando a tutti di comprenderli e rispettarli.” (L. Labor, Le ACLI per la partecipazione dei lavoratori alla società democratica, relazione introduttiva al X congresso nazionale delle ACLI, 3 novembre 1966, in Scritti e discorsi, vol. 1, pp. 492-523, alle pp. 521-22; AS 20 novembre 1966, p. 5). Poco prima aveva accomunato la DC agli altri partiti, accusati di un “eccesso di chiusura nei metodi sinora messi in atto dalle classi dirigenti e dai gruppi che esercitano il potere.” Tutto ciò ha “impedito il ricambio, ha frenato lo slancio e l'adesione di quanti, con un clima, metodi e strategie diversi, sarebbero stati indotti, per vocazione o per scelta razionale ad impegnarsi nei partiti, come canali di partecipazione politica, recandovi un apporto nuovo, un soffio di vitalità.” (Ivi, p. 499). Invece, “occorre un impegno severo e continuo […] per impedire che la partecipazione venga a identificarsi con una integrazione passiva e strumentale, addormentatrice del compito di protagonisti, come persone e come gruppo, che appartiene ai lavoratori come a tutti i cittadini […e] che le ACLI debbono, e quindi possono, assolvere.” (Ivi, p. 495).
Durante la lettura della lunga relazione introduttiva di Labor, mons. Franco Costa, assistente generale dell'Azione Cattolica italiana, che sedeva tra gli ospiti ufficialmente invitati, abbandona platealmente la sala, perché si era stancato di “assistere ad un congresso politico”, (D. Rosati, La questione politica delle ACLI, Dehoniane, Napoli 1975, p. 145) segno evidente che alcuni esponenti ecclesiastici coglievano con disappunto una sorta di mutazione genetica delle ACLI, che ne accentuava la politicizzazione. Il dibattito nelle giornate congressuali lascia trasparire una crescente delusione nei confronti della DC, al punto che Labor, prima della replica finale, dopo un breve scambio di opinioni con i suoi più stretti collaboratori (Carboni, Borrini, Gabaglio, Brenna, Pozzar e Rosati), in un ristorante dell'EUR, come ricorda Rosati stesso, (Ivi, p. 145) decide di intervenire per frenare le intemperanze dei delegati, i quali, oltre a Rumor, avevano fischiato anche il segretario generale della CISL, Bruno Storti, ritenuto corresponsabile delle lentezze e dei ritardi con cui si stava avviando il percorso di unificazione tra le tre grandi confederazioni sindacali (Storti verrà ulteriormente umiliato dai delegati, che nelle votazioni per il rinnovo del Consiglio nazionale delle ACLI, gli faranno mancare in massa le preferenze, relegandolo al 42° posto, su 45 uomini eletti). In sostanza Labor decide di invitare esplicitamente, in sede di replica, i deputati aclisti a rimanere impegnati nel partito, nella consapevolezza che, benché fossero state poste le premesse per un distacco dalla DC se questa non fosse stata in grado di realizzare la linea delle riforme e della pianificazione democratica, i tempi per la rottura definitiva non erano ancora maturi, e inoltre mancando poco più di un anno alle elezioni politiche, per il momento non c'erano alternative. Nella replica torna inevitabilmente ai fischi rivolti a Rumor: “Lasciate ora che io vi esprima una mia interpretazione dell'accoglienza che l'assemblea ha riservato all'on. Rumor. Certo una parte di voi non desidera oggi, per ora, rifare un'esperienza nella DC; in buona parte avete ritenuto di esprimere una critica, non tanto al segretario del partito quanto al capo di quella che era un corrente di maggioranza [cioè i dorotei] del partito. Ma certamente voi tutti avete inteso sottolineare che attendete tutto il partito della Dc e tutta la sua classe dirigente alla prova dei fatti. […] Confermiamo perciò che non concederemo a nessuno l'appalto della guida sociale e politica dei lavoratori cristiani; che non ci riconosceremo se non là dove i valori, di cui siamo portatori, vedremo affermati...” (L. Labor, Replica al X congresso nazionale delle ACLI, in Scritti e discorsi, vol. 1, pp. 523-28, alla p. 525).
Pochi giorni dopo ritorna sul tema in una lettera riservata ai suoi più stretti collaboratori, nella quale afferma che il clima di cristiana libertà della sua coscienza è stato “notevolmente turbato” dalle intemperanze congressuali, che hanno rischiato “forse incoscientemente, di far franare perfino l'omogeneità culturale, morale e spirituale che per anni tutti e con tanti sacrifici abbiamo perseguito.” E aggiunge: “Mi sono trovato impotente e senza efficaci aiuti ad evitare due episodi in particolare, che personalmente ritengo inutili, irresponsabili ed anzi controproducenti: il rumoreggiamento di Rumor e la mancata votazione di Storti.” (Lettera di Livio Labor del 15 novembre 1966, in M. C. Sermanni, Le Acli. Alla prova della politica, Dehoniane, Napoli 1986, pp. 185-86, n. 31).
La mozione congressuale è approvata unanimemente e l'esito delle votazioni mostra che i parlamentari godono ancora di un largo consenso interno (Vittorino Colombo arriva secondo, subito dopo Labor, Giovanni Bersani quarto), anche se la minoranza del congresso di Bari ormai è politicamente dissolta e Livio Labor è il leader incontrastato del movimento. Infatti il Consiglio nazionale del 19 novembre 1966 lo rielegge presidente, con una mole di consensi quasi plebiscitaria (70 voti su 77 presenti, con 6 schede bianche e un voto disperso) segno che la sua strategia complessiva è largamente condivisa (VCN del 19 novembre 1966, in ASA, Serie organi statutari, b. 6, fasc. 1966; AS 27 novembre 1966, p. 3).
Il nuovo Comitato esecutivo delle ACLI è ricevuto in udienza privata da Paolo VI. L'udienza si protrae a lungo: il pontefice fa sedere gli ospiti e ascolta con pazienza il resoconto del recente congresso nazionale delle ACLI. Il Papa parla dell'importanza della formazione cristiana dei giovani, rievoca i suoi frequenti contatti con le ACLI quando era arcivescovo di Milano, e anche “i convegni festosi” per l'iscrizione dei giovani lavoratori, ricorda le origini del movimento e le sue finalità (definendo le ACLI come “benemerite associazioni”), insiste sull'apostolato d'ambiente e sull'importanza del dialogo con le altre associazioni cattoliche. (AS, 27 novembre 1966, p. 2. Nella stessa pagina è riportato quasi integralmente il comunicato de «L'Osservatore Romano»). Secondo la testimonianza di Rosati, il commento sui risultati del X Congresso nazionale è molto sintetico: il Papa si limita ad affermare che “siete andati ad extra, su un terreno sul quale noi preti non possiamo né approvarvi, né disapprovarvi.” (D. Rosati, La questione politica delle ACLI, p. 147). Questa frase è interpretata dal gruppo dirigente delle ACLI come una constatazione, totalmente condivisibile, del fatto che le scelte opinabili prese dal congresso nell'ambito politico e sindacale non debbano in alcun modo coinvolgere la gerarchia. Infatti, nello stesso numero di Azione Sociale che riferisce dell'incontro col Pontefice, è pubblicata una nota, rivista ed approvata dallo stesso Labor, in cui, dopo aver apprezzato l'attenzione di Paolo VI per i problemi delle ACLI, si afferma che: “in rapporto a temi, come quelli politici e sindacali, sui quali non operiamo direttamente […] ma sui quali sentiamo almeno di avere opinabili indicazioni da esprimere in modi debiti ed efficaci, propri di un movimento sociale di lavoratori cristiani […] l'errore sarebbe quello di pretendere di coinvolgere, in queste opinabili valutazioni, la Chiesa e la Gerarchia; e sarebbe oltretutto un andare contro il Concilio.” (AS, 27 novembre 1966). In effetti il tema del presunto coinvolgimento della gerarchia in scelte politiche e sindacali opinabili è al centro di molti interventi critici provenienti dal mondo cattolico ed in particolare dalla Gioventù d'AC e dalla FUCI. (Le ACLI, un discorso da aprire, in «Gioventù», 1 dicembre 1966; Per le ACLI si impone una scelta, «Ricerca», 15 novembre 1966). La risposta è affidata ad un ampio e articolato scritto di Emilio Gabaglio: “E' inaccettabile l'insinuazione di una nostra strumentalizzazione della Gerarchia o dell'uso a fini solo «suggestivi» che noi faremmo del nome cristiano. Né abbiamo mai preteso di realizzare in nome del Cristianesimo e su scelte opinabili l'unità dei «lavoratori cristiani», prova ne sia che ci sono molti cristiani lavoratori, anche militanti, che si guardano bene dall'iscriversi alle ACLI. Chi viene con noi ci viene per libera scelta, in considerazione degli orientamenti che andiamo sostenendo nel movimento operaio e nella società italiana, nell'elaborazione dei quali ovviamente l'ispirazione sociale cristiana non è per noi elemento indifferente o di puro contorno.” (E. Gabaglio, Le ACLI sanno scegliere, in AS, 18 dicembre 1966, p. 3).
La recezione del Concilio e la Populorum progressio
L'8 dicembre 1965, festa dell'Immacolata, Paolo VI chiude solennemente il Concilio Vaticano II. Livio Labor sembra consapevole della straordinaria importanza del concilio per la Chiesa in generale e per l'azione sociale dei lavoratori cristiani e si impegna affinché le ACLI ne interiorizzino i risultati. Il 12 dicembre invia un telegramma al Pontefice per ringraziarlo del messaggio ai lavoratori e afferma che “impegna Movimento tutto [ad] approfondire e verificare suo ruolo in rinnovata luce Costituzioni e Decreti conciliari.” (AS, 19 dicembre 1965, p. 3). Pochi giorno dopo, nel radiomessaggio per gli auguri di inizio anno, il presidente delle ACLI mette in luce l'importanza del 1965 in relazione alla conclusione del Concilio, “fatto particolarmente importante, che le ACLI sottolineano perché riguarda anche tutti i lavoratori.” Labor ricorda che il Concilio “ha sancito l'impegno della Chiesa e di tutti i cristiani ad un dialogo intenso e coraggioso con il mondo moderno in tutte le sue espressioni e quindi anche con quelle sindacali che rappresentano una così importante componente della moderna società.” (L. Labor, Auguri del presidente nazionale delle ACLI ai lavoratori italiani per il nuovo anno, trasmesso dalla rubrica RAI La voce dei lavoratori, 29 dicembre 1965, in Scritti e discorsi, vol. 1, p. 468).
Nell'ampia relazione introduttiva al X congresso nazionale, già citata per gli aspetti che riguardano le critiche alla DC, Labor delinea con precisione le conseguenze degli orientamenti conciliari sulla vita e sull'azione sociale delle ACLI: “Nel definire il ruolo dei laici e nell'affidare ad essi un compito di apostolato, di animazione cristiana dell'ordine temporale, il Concilio ci ha resi ancor più avvertiti della inesistenza di un solo modello personale o di gruppo a cui ispirarsi; l'azione sociale cristiana si esercita così su una molteplicità di scelte tutte lecite e possibili, mentre attua la scoperta del valore delle realtà temporali. In questa luce i laici sono coscienti sperimentatori di nuove sintesi sociali e culturali in un atteggiamento di dialogo col mondo. Tre posizioni pratiche […] emergono dopo il Concilio: quella di coloro che dicono le parole del Concilio sognando che esse taumaturgicamente abbiano già mutato la realtà; di coloro che le ripetono, augurandosi che tutto cambi il meno possibile; di coloro che forse le recitano meno spesso, ma in compenso si impegnano con pazienza per attuare il messaggio conciliare. Noi ci sentiamo tra questi ultimi, anche perché il Concilio non è stato per noi, come forse per altri, un terremoto: nella casa del Concilio ci siamo trovati subito a nostro agio. Dal Concilio sentiamo infatti convalidata la nostra tensione a moltiplicare il numero dei militanti operai autenticamente cristiani, operanti in uno specifico terreno d'azione squisitamente temporale; sentiamo confermato il nostro metodo pedagogico, organizzativo, di azione sociale cristiana […]; e ci sentiamo rincuorati a proseguire, come obiettivo prioritario del Movimento […l'] azione sociale di base […] per effettivamente tentare di rovesciare il pigro ritmo tradizionale di sviluppo delle organizzazioni democratiche, stimolando la partecipazione dal basso....” (L. Labor, Le ACLI per la partecipazione dei lavoratori alla società democratica, relazione introduttiva al X congresso nazionale delle ACLI, 3 novembre 1966, in Scritti e discorsi, vol. 1, pp. 516-17).
Tra tutti gli orientamenti emersi dal Concilio, due aspetti toccano più direttamente le ACLI come movimento di lavoratori cristiani: il ruolo dei laici nella Chiesa e nell'apostolato (definito dal decreto Apostolicam actuositatem) e i rapporti tra la Chiesa e la società contemporanea (trattati nella costituzione pastorale Gaudium et spes). Per quanto riguarda il ruolo dei laici cristiani, le ACLI trovano nel Concilio la piena conferma dei propri ideali e dei principi costitutivi della loro stessa ragion d'essere. Non solo infatti il decreto Apostolicam actuositatem afferma che l'apostolato dei laici deve essere “più intenso e più esteso” e ribadisce il dovere di animare cristianamente l'ordine delle realtà temporali, nel rispetto “integrale” di principi propri di tali realtà, ma anche ricorda a tutti il dovere assoluto di esercitare la carità e precisa: “Affinché tale esercizio di carità possa essere al di sopra di ogni critica […] si abbia estremamente riguardo della libertà e della dignità della persona che riceve l'aiuto; […]; siano anzitutto adempiuti gli obblighi di giustizia, perché non avvenga che offra come dono di carità ciò che è già dovuto a titolo di giustizia; si eliminino non soltanto gli effetti ma anche le cause dei mali; l'aiuto sia regolato in tal modo che coloro i quali lo ricevono vengano, a poco a poco, liberati dalla dipendenza altrui e diventi sufficienti a se stessi.” (Apostolicam actuositatem, Decreto sull'apostolato dei laici, 18 novembre 1965, n. 8).
In fondo questo è il punto di vista a cui le ACLI si erano ispirate fin dalle origini: non solo assistere i lavoratori tramite i servizi, come il Patronato, le cooperative ed altri strumenti, ma anche agire socialmente per trasformare la società, per eliminare non solo gli effetti, ma anche le cause strutturali, economiche che causano le ingiustizie sociali. Non solo: l'esplicito riconoscimento dell'insostituibilità delle forme organizzate e associative d'apostolato dei laici cristiani nel mondo del lavoro sembra sottolineare l'importanza e la validità della stessa esperienza aclista. Per quanto riguarda le parti della Gaudium et spes che trattano in particolare l'economia e i diritti dei lavoratori, gli aclisti vi ritrovano con soddisfazione non solo la conferma dei principi fondamentali della dottrina sociale delle Chiesa (dalla Rerum novarum di Leone XIII alla Pacem in terris di Giovanni XXIII) con i temi che già avevano ampiamente discusso nei primi anni Sessanta, in occasione delle due encicliche di papa Giovanni, ma anche ulteriori motivazioni e stimoli per la loro azione sociale. In particolare l'insistenza con cui le ACLI avevano negli ultimi anni criticato e contrastato il liberismo economico, sostenendo la necessità di una pianificazione democratica e di una autentica partecipazione del movimento dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi della programmazione, e così motivando la loro convinta adesione al centro sinistra, sembrano trovare pieno sostegno nella costituzione pastorale approvata dal Concilio: “Lo sviluppo economico deve rimanere sotto il controllo dell'uomo. Non deve essere abbandonato all'arbitrio di pochi uomini o gruppi che abbiano in mano un eccessivo potere economico, né della sola comunità politica, né di alcune nazioni più potenti. Conviene, al contrario, che il maggior numero possibile di uomini, a tutti i livelli e, quando si tratta dei rapporti internazionali, tutte le nazioni possano partecipare attivamente al suo orientamento. È necessario egualmente che le iniziative spontanee dei singoli e delle loro libere associazioni siano coordinate e armonizzate in modo conveniente ed organico con la molteplice azione delle pubbliche autorità. Lo sviluppo economico non può essere abbandonato né al solo gioco quasi meccanico della attività economica dei singoli, né alla sola decisione della pubblica autorità. Per questo, bisogna denunciare gli errori tanto delle dottrine che, in nome di un falso concetto di libertà, si oppongono alle riforme necessarie, quanto delle dottrine che sacrificano i diritti fondamentali delle singole persone e dei gruppi all'organizzazione collettiva della produzione.” (Gaudium et spes, Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, 7 dicembre 1965, n. 65).
Labor insiste in più occasioni sull'importanza di questo paragrafo e del suo contenuto; lo legge integralmente, ad esempio, nella replica al convegno di studi di Vallombrosa del 1966, già richiamata più sopra, a sostegno della visione sociale delle ACLI. (QAS, 1966, n. 3, p. 547). L'esigenza della subordinazione dell'economia ai valori dell'integrale ed autentico sviluppo della persona umana è fatta discendere dal concilio direttamente dal significato cristiano dell'umana dignità: “Cresce la coscienza dell'eminente dignità della persona umana, superiore a tutte le cose e i cui diritti e doveri sono universali e inviolabili. Occorre perciò che sia reso accessibile all'uomo tutto ciò di cui ha bisogno per condurre una vita veramente umana, come il vitto, il vestito, l'abitazione, il diritto a scegliersi liberamente lo stato di vita e a fondare una famiglia, il diritto all'educazione, al lavoro, alla reputazione, al rispetto, alla necessaria informazione, alla possibilità di agire secondo il retto dettato della sua coscienza, alla salvaguardia della vita privata e alla giusta libertà anche in campo religioso. L'ordine sociale pertanto e il suo progresso debbono sempre lasciar prevalere il bene delle persone, poiché l'ordine delle cose deve essere subordinato all'ordine delle persone e non l'inverso.” (Gaudium et spes, n. 26) Ne conseguono dirette implicazioni sul piano della giustizia sociale: “Dio ha destinato la terra e tutto quello che essa contiene all'uso di tutti gli uomini e di tutti i popoli, e pertanto i beni creati debbono essere partecipati equamente a tutti, secondo la regola della giustizia, inseparabile dalla carità. Pertanto, quali che siano le forme della proprietà, adattate alle legittime istituzioni dei popoli secondo circostanze diverse e mutevoli, si deve sempre tener conto di questa destinazione universale dei beni. L'uomo, usando di questi beni, deve considerare le cose esteriori che legittimamente possiede non solo come proprie, ma anche come comuni, nel senso che possano giovare non unicamente a lui ma anche agli altri. Del resto, a tutti gli uomini spetta il diritto di avere una parte di beni sufficienti a sé e alla propria famiglia.” (Ivi, n. 69)
In effetti se si esaminano le iniziative formative dell'anno sociale 1965-66, cioè quello della conclusione del Concilio, relativamente alle ACLI milanesi, unica realtà locale di cui si ha completa documentazione si può verificare come tutta l'attenzione, salvo qualche limitata riflessione sulla Lumen gentium, si concentri sui due documenti citati. (P. Brugnoli, Le ACLI e il Concilio, ACLI, Milano 1966, che contiene la documentazione degli incontri promossi dalle ACLI milanesi sul Concilio) Per molti dirigenti e quadri aclisti il Concilio assume dunque un significato di cambio di mentalità poiché essi sentono che tra la realtà terrena, vissuta come quotidiano impegno sindacale, sociale e politico, e la speranza sopranaturale vissuta nell'esperienza di fede, non c'è più quel distacco percepito magari in modo non esplicito e non concettualizzato negli anni precedenti. Specialmente negli educatori che insegnano nelle molteplici occasioni formative delle ACLI, sia a livello nazionale sia locale, si manifesta l'intima convinzione della novità del messaggio conciliare per quanto riguarda il dialogo tra la Chiesa e il mondo, strettamente intrecciata alla consapevolezza che essa era già stata presente e vissuta nella loro azione sociale, sia pure in nuce e in modo non del tutto consapevole. Sempre sul piano dei contenuti della formazione aclista negli anni immediatamente successivi al Concilio, l'autonomia di giudizio dei laici nelle scelte temporali è uno dei temi più dibattuti: si prende gradualmente consapevolezza che la dottrina sociale cristiana tradizionalmente insegnata dalla Chiesa, per quanto indispensabile per orientare l'azione sulla base dei principi e dei valori, non può fornire soluzioni specifiche adatte a risolvere in modo insindacabile ogni problema economico o sociale e pertanto la responsabilità dei laici cristiani in scelte opinabili assume un valore centrale e crescente.
Poco più di un anno dopo la conclusione del Concilio, il 26 marzo 1967, Paolo VI pubblica l'enciclica sociale Populorum progressio, che sulla base degli orientamenti conciliari, in particolare delle tesi della costituzione Gaudium et spes, affronta il grave problema del sottosviluppo di larga parte dell'umanità, con le drammatiche conseguenze della fame, della ricchezza, dell'analfabetismo, delle malattie endemiche. In generale, l'enciclica non si limita ad analizzare la questione del sottosviluppo, ma contiene una forte esortazione all'intervento ed al cambiamento: “Si tratta di un insegnamento di particolare gravità che esige un’applicazione urgente. I popoli della fame interpellano oggi in maniera drammatica i popoli dell’opulenza. La chiesa trasale davanti a questo grido d’angoscia e chiama ognuno a rispondere con amore al proprio fratello.” (Populorum progressio, 26 marzo 1967, n. 3). E ancora: “La situazione presente dev'essere affrontata coraggiosamente e le ingiustizie, che essa comporta, combattute e vinte. Lo sviluppo esige trasformazioni audaci, profondamente innovatrici. Riforme urgenti devono essere intraprese senza indugio. A ciascuno l'assumersi generosamente la sua parte...” (Ivi, n. 32).
Fin dalla sua pubblicazione, l'enciclica è percepita come un fortissimo richiamo alla coscienza dei Paesi industrializzati, dominanti nell'economia internazionale, affinché attuino una politica economica più giusta verso quelli sottosviluppati, e da questo punto di vista registra un altissimo consenso dell'opinione pubblica interna ed esterna, sicuramente il più ampio di tutto il pontificato. E tuttavia per la sua radicalità l'enciclica è accolta con diffidenza e talvolta con malcelate critiche dagli ambienti della destra economica e politica. Infatti il testo di Paolo VI esprime nel modo più perentorio la critica al liberismo economico ed alla tesi dell'assoluto diritto di proprietà che era già presente nelle encicliche giovannee e nelle conclusioni del Concilio: “Si sa con quale fermezza i padri della chiesa hanno precisato quale debba essere l’atteggiamento di coloro che posseggono nei confronti di coloro che sono nel bisogno: «non è del tuo avere», afferma sant’Ambrogio, «che tu fai dono al povero; tu non fai che rendergli ciò che gli appartiene. Poiché è quel che è dato in comune per l’uso di tutti, ciò che tu ti annetti. La terra è data a tutti, e non solamente ai ricchi». È come dire che la proprietà privata non costituisce per alcuno un diritto incondizionato e assoluto. Nessuno è autorizzato a riservare a suo uso esclusivo ciò che supera il suo bisogno, quando gli altri mancano del necessario. In una parola, il diritto di proprietà non deve mai esercitarsi a detrimento della utilità comune”. (Ivi, n. 23).
Solo quattro anni prima, al tempo della Pacem in terris, le ACLI non avevano ancora sviluppato, almeno nelle strutture periferiche, una attenta sensibilità agli aspetti globali, internazionali della questione sociale e quindi non erano in grado di recepire significativamente tutte le implicazioni della dottrina sociale della Chiesa, come si è visto. A metà degli anni Sessanta, invece, grazie alle sollecitazioni della presidenza nazionale e anche alla mutata sensibilità dell'opinione pubblica, la situazione era decisamente migliorata: centinaia di migliaia di lavoratori cattolici, nei circoli ACLI di tutta Italia, si autotassavano per finanziare le iniziative culturali e sociali dei movimenti operai cristiani nei Paesi in via di sviluppo, soprattutto in America Latina. (L. Labor, La Populorum progressio esige una risposta concreta, in AO, 12 aprile 1967, in Scritti e discorsi, vol. 1, pp. 529-30, alla p. 529). Il Comitato esecutivo delle ACLI accoglie “con gioia e commozione la promulgazione dell'enciclica” e “fa proprio l'appello di S. S. Paolo VI e chiama i lavoratori aclisti ad accrescere il loro impegno culturale, politico e di solidarietà a sostegno delle attività d'aiuto e di cooperazione sul piano formativo e sociale con i movimenti operai e contadini cristiani dei Paesi in via di sviluppo.” (AS, 9 aprile 1967, p. 3). Con i fondi raccolti si organizzano, tra l'altro, corsi di formazione in Italia per i quadri della Confederazione dei sindacati cristiani in America Latina (CLASC). Nello stesso numero di Azione sociale che riporta il comunicato dell'esecutivo, è pubblicato il testo integrale dell'enciclica, accompagnato sia da un ampio dossier ricco di dati, in particolare sul reddito, l'analfabetismo e gli aiuti internazionali di 21 Paesi africani, 16 asiatici e 18 del centro e sud America, sia dal commento di mons. Pagani, che sottolinea come il discorso del Papa “può sembrare incomprensibile, duro, estemporaneo: qualcuno Gli rimprovererà forse di mortificare in radice lo slancio umano, in nome di valori forse chimerici; altri potranno offendersi perché il Suo richiamo sembra colpirli negli affari quotidiani; […] alcuni si schermiranno con disinvoltura nel ricordo di altri richiami precedenti altrettanto solenni nel loro contenuto e facilmente archiviati dal popolo cristiano. Cioè laicisti, liberisti, marxisti e sedicenti cristiani si muoveranno su strade diverse per tentare un'unica meta: svuotare il messaggio pontificio del suo intimo significato.” (Ivi, pp. 7-14 il testo dell'enciclica; pp. 15-26 il dossier con i dati; p. 3 il commento di mons. Pagani). Il successivo numero di Azione sociale è quasi interamente dedicato all'Africa, e riflessioni e commenti sull'enciclica non mancheranno nelle settimane successive.
Nonostante la sentita attenzione delle ACLI per l'enciclica, il presidente Labor rileva con preoccupazione la sordità di larga parte della società italiana e del mondo cattolico stesso, rispetto al messaggio di Paolo VI, che “mette in crisi la coscienza dei benpensanti e dei possidenti”, e che esige risposte immediate e concrete nell'azione quotidiana: “Un documento come la Populorum progressio non può essere commentato o sezionato per accettarne una parte e respingerne un'altra. Proprio il carattere eminentemente pastorale dell'enciclica esige dagli uomini cui si rivolge non tanto un'adesione ideale, quanto una risposta pratica. Paolo VI ha lanciato un appello al quale non sembra possibile reagire se non con il metro evangelico del sì o del no. Ed è la constatazione dell'assenza di qualche sì nel campo delle reazioni pratiche – iniziative, progetti, stanziamenti – che autorizza l'amaro rilievo sulla permanente sordità dell'ambiente.” (L. Labor, La Populorum progressio, p. 529). Tra le possibili iniziative concrete, il presidente nazionale insiste sulla proposta di riduzione del 0,5% delle spese militari italiane per destinare la somma così recuperata al fondo sociale dell'ONU per la lotta contro il sottosviluppo: “Questa proposta ha il pieno appoggio delle ACLI, non solo perché porta la firma di molti deputati provenienti dalla file del Movimento, ma perché è stata discussa, sollecitata ed apprezzata dai lavoratori cristiani a tutti i livelli. Anche altri settori dell'opinione pubblica si sono dimostrati favorevoli allo spirito dell'iniziativa ed al significato della proposta.” (Ivi, p. 530).
Le elezioni politiche del 1968 e la nascita dell'ACPol
Mentre in tutte le altre precedenti elezioni politiche era considerato pacifico che una pattuglia di esponenti aclisti fosse candidata nelle liste della DC, nella fase di preparazione alle elezioni del 19 maggio 1968 si sviluppa invece un dibattito sul significato di tale presenza e sui requisiti necessari per definire aclista una candidatura. Per la prima volta si afferma ufficialmente che la scelta di candidare degli aclisti nelle liste della DC è contingente, limitata alle elezioni del 1968, e non una scelta permanente. Nel Comitato esecutivo del 25 e 26 novembre 1967 sono precisati nel dettaglio sia le condizioni che il mandato dei candidati aclisti, che devono essere “pochi, ma qualificati e qualificanti.” (Allegato alla convocazione del Comitato Esecutivo del 25 e 26 novembre 1967, in ASA, Serie organi statutari, b. 19). La qualifica di candidato aclista può essere attribuita dal Comitato esecutivo, su proposta del competente Consiglio provinciale, a chi ha fatto parte degli organi delle ACLI per almeno tre anni, accertata “l'assenza di legami prioritari già preventivamente stabiliti con altre organizzazioni di massa”. Il Comitato esecutivo scoraggia la candidatura dei presidenti provinciali in carica, perché dovrebbero immediatamente dimettersi, e invita le strutture locali ad “evitare i pericoli di una strumentalizzazione delle nostre organizzazioni periferiche.” I candidati aclisti devono chiedere il consenso agli elettori sulla base di una dichiarazione programmatica comune, che rileva esplicitamente che “le grandi speranze che l'avvio dell'esperienza politica del centro sinistra aveva suscitato tra i lavoratori e nelle classi popolari si sono solo in parte realizzate” e che prende atto del “ritardo con cui sono state avviate alcune riforme.” Di conseguenza, a differenza delle precedenti elezioni, è assegnato un preciso mandato politico ai futuri parlamentari aclisti: “Si impone pertanto una inversione di tendenza, che elimini il progressivo attenuarsi della carica innovativa del centro sinistra.” (Bozza di dichiarazione programmatica, allegata al verbale del CE del 25 e 26 novembre 1967).
Sul successivo numero di Azione sociale troviamo un ultimatum ancor più esplicito verso la DC, ancor più rilevante se si tiene presente che i vescovi italiani avevano ribadito la validità dell'unità politica dei cattolici: “Dovremo quindi chiederci in futuro cosa le ACLI possono fare per contribuire ad un diverso assetto della vita politica […] con la sola preoccupazione di promuovere la condizione umana e sociale dei lavoratori.” (AS, 17 dicembre 1967, p. 12). Livio Labor afferma senza mezzi termini che la “tradizionale indicazione elettorale” verso la DC è “fondata su caratteri nuovi: non una «scommessa» su un partito, ma una scelta contingente e condizionata.” (Ivi, p. 3). Alle prospettive future allude velatamente ancora Labor, in un discorso ad Ascoli Piceno, pochi giorni prima delle elezioni: “Il concetto della libertà di voto - parlo non di libertà politica ma di libertà psicologica - è ancora in gran parte da valorizzare in Italia. In questa campagna elettorale […] le ACLI hanno dato […] un contributo al recupero di questo concetto che rende, ad un tempo, meno emotivo e più significativo il contenuto delle loro scelte elettorali. E' un apporto utile per il superamento di quel bagaglio mitologico di cui la maturazione democratica deve liberare la nostra vita politica per esaltare appunto il valore della libertà di scelta dei singoli e, come nel caso delle ACLI, delle comunità associative.” (AO, 18 maggio 1968). Per quanto non definitivo, il sostegno elettorale delle ACLI alla DC è comunque deciso e operativo in tutto il territorio nazionale. Ai presidenti provinciali sono date disposizioni precise: “le ACLI sono impegnate ad orientare il voto degli iscritti e dei lavoratori verso le liste della DC” e “nelle circoscrizioni in cui vi sono candidati aclisti, le ACLI sono impegnate [sottolineato nel testo] in quanto organizzazione […] ad adoperarsi per assicurarne l'elezione.” (Lettera di Marino Carboni, segretario nazionale, ai presidenti provinciali del 5 aprile 1968, in ASA, Serie organi statutari, b. 7, fasc. CN del 9-10 dicembre 1967).
L'unica situazione parzialmente dissonante è quella di Milano, dove il presidente regionale Gian Mario Albani si dimette dalla carica per accettare, come indipendente, la candidatura al Senato nelle lista del PCI. Subito sconfessato, Albani è accusato d'incoerenza, poiché il 19 febbraio aveva approvato il documento delle ACLI milanesi che esprimeva esplicita indicazione di voto per la DC. Le ACLI giudicano strumentale e ipocrita l'appellarsi da parte di Albani alla libertà di coscienza, in quanto il dissenso individuale è moralmente accettabile “finché si manifesta nelle sedi apposite del dibattito, ma è impossibile accettare che atti esterni di rilievo contraddicano così palesemente una linea ampiamente dibattuta e democraticamente fissata.” Vi è anche la preoccupazione che l'episodio possa fornire alla stampa di destra e agli ambienti tradizionalisti del mondo cattolico un pretesto per sostenere che le ACLI sono ormai un pericolo, un covo di potenziali comunisti. Per questo, nello stesso collegio di Albani è candidato per la DC il vicepresidente delle ACLI Vittorio Pozzar. Per questo, con grande evidenza, Azione sociale dà notizia che la presidenza provinciale delle ACLI milanesi “ha dato conferma del suo preciso orientamento a favore delle liste della DC” e che il cardinale arcivescovo di Milano, Giovanni Colombo, nell'incontro con la presidenza e il Consiglio provinciale delle ACLI, nei confronti di Albani, “si è detto addolorato ma non scandalizzato […] e ha espresso con ferma chiarezza le motivazioni che rendono moralmente errata e inaccettabile la sua scelta, pur avendo per la sua persona accenti di grande comprensione pastorale.” (AS, 24 marzo 1968, p. 15). Complessivamente alle elezioni del 19 maggio 1968 vi sono 28 candidati ufficialmente aclisti alla Camera e 2 al Senato; in realtà non tutti coloro che avevano i requisiti son considerati tali, poiché in alcuni casi sporadici i consigli provinciali delle ACLI non concedono il loro appoggio (ad esempio Michele Capra, ex presidente provinciale di Brescia, verrà ugualmente eletto alla Camera, ma senza il sostegno ufficiale delle ACLI). Complessivamente sono eletti 19 deputati e un senatore (che è il vicepresidente Vittorio Pozzar, che si era dimesso per candidarsi, mentre Alberto Silvestrini, delle ACLI di Grosseto, candidato in un collegio incerto, non è eletto). Lo stesso Labor non nasconde la soddisfazione per il risultato ottenuto: “Nelle 15 circoscrizioni [su 32] in cui si presentavano candidati aclisti questi hanno ottenuto complessivamente oltre un milione di voti […mentre] nelle stesse circoscrizioni i tesserati delle ACLI sono 452.522” (AS, 30 giugno 1968). Gli iscritti complessivi delle ACLI erano 628.307, tesseramento 1967; il dato citato da Labor si ottiene sottraendo gli iscritti delle regioni Val d'Aosta, Trentino, Friuli, Umbria, Abruzzo, Molise e quelli delle circoscrizioni per la Camera di Cuneo, Mantova, Pisa e Siena, dove non erano presenti candidati aclisti.
Il lento e progressivo manifestarsi del dissenso delle ACLI verso la linea politica della DC trova un ulteriore significativo momento nell'annuale incontro di studi delle ACLI a Vallombrosa (dal 28 agosto al 1 settembre 1968) sul tema Impresa, movimento operaio, piano, a cui partecipano 285 dirigenti aclisti, tra cui 48 presidenti provinciali e 179 consiglieri provinciali del movimento, assieme a 26 assistenti ecclesiastici e 43 invitati (sindacalisti ed esperti economici e sociali) Tra le quattro relazioni, introduttive alle quattro giornate, particolarmente significative sono quelle di Ettore Morezzi, presidente delle ACLI di Torino, che Labor avrebbe desiderato come suo successore, e di Geo Brenna, responsabile nazionale dell'ufficio studi. La relazione di Morezzi, che tratta il tema della conflittualità nell'impresa e nella società, è un documento eloquente della radicalizzazione della prospettiva politica e sindacale delle ACLI in quella fase di dure e diffuse lotte operaie e studentesche (AS, 8 settembre 1968). Brenna, che tratta invece il tema della programmazione economica, denuncia il sempre più marcato declino delle finalità originarie del centro sinistra, poiché la pianificazione democratica come metodo è stata svuotata e ha perduto ogni priorità nell'agenda di governo. La classe politica è diventata incapace di interpretare le aspirazioni più profonde dei lavoratori: “la crisi di sommovimento della società italiana deve passare anche per una crisi di rinnovamento delle attuali forze politiche.” (AS, 8 settembre 1968, pp. 19-20). Tocca a Labor, come presidente nazionale, concludere i quattro giorni di appassionate discussioni, con una sintesi e una proposta che faranno a lungo discutere: “Il potere imprenditoriale autoritario ed assoluto va contestato non solo nell'impresa ma anche nella società; […] nuove forme di partecipazione vanno conquistate con la contestazione creativa, con l'invenzione di nuovi strumenti e canali politici; […] occorrerà perciò che i lavoratori e quindi anche gli uomini delle ACLI e di tutto il movimento operaio esprimano […] piattaforme articolate e differenziate, funzionali alle risposte politiche esigite dalle realtà locali e regionali, nonché uomini e classe dirigente che con tali piattaforme facciano corpo. Non crollerà la democrazia in Italia se su tali linee verranno inventati canali nuovi di partecipazione per una più diretta democrazia di base e nuovi giocatori entreranno nel gioco democratico a carte scoperte.” (Replica del Presidente nazionale, in AS, 8 settembre 1968, p. 31). Una posizione del genere può essere interpretata come un auspicio alla creazione di una nuova forza politica espressione del movimento dei lavoratori, come se fosse definitivamente accertato che né la DC, né i tradizionali partiti di sinistra siano in grado di rappresentare pienamente i valori autentici dei lavoratori e le speranze popolari di trasformazione della società. In molti ambienti cattolici, come mostrano i commenti delle riviste, come la Civiltà Cattolica, riemerge la preoccupazione che le ACLI possano presentare liste alternative alla DC nelle elezioni amministrative o addirittura fondare un secondo partito cattolico. (G. De Rosa, Convegno delle ACLI su impresa, movimento, piano, in «La Civiltà Cattolica», 1968, n. 3, pp. 519-528; M. Reina, Dopo Vallombrosa, i dirigenti aclisti a un bivio, in «Aggiornamenti Sociali», ottobre 1968, pp. 563-74).
In realtà l'intenzione di Labor è di promuovere un generale rimescolamento di carte: la convinzione è che nella DC (la corrente di Forze Nuove di Donat-Cattin, Vittorino Colombo e Guido Bodrato), nell'area socialista (la sinistra lombardiana del PSI e Lelio Basso dello PSIUP) e nella CISL (la minoranza interna, critica verso la segreteria Storti, che vuole più decisione nel processo d'unificazione sindacale) vi sia un ampio schieramento profondamente deluso dall'involuzione moderata del centro sinistra e potenzialmente in grado di contribuire a creare una nuova forza politica capace di esprimere realmente le esigenze di cambiamento che provenivano dal movimento dei lavoratori. Questo è verosimilmente il senso più autentico di un passaggio della replica di Labor a Vallombrosa, che appare per certi versi ambiguo e allusivo: “Prima ancora che alla riforma dello Stato, insomma, è tempo di pensare ad una riforma della politica: ad una nuova dislocazione di forze, cioè, capace di rappresentare realmente le istanze nuove presenti nel Paese, cominciando con l'enucleare almeno nel dibattito e nel confronto culturale e politico, tutte le forze di sinistra democratica.” (Replica del Presidente nazionale, in AS, 8 settembre 1968, p. 31). Va osservato che la prospettiva così prudentemente proposta da Labor preoccupa sommamente tutti i grandi partiti popolari: la DC e il PSI che si indebolirebbero con la perdita delle rispettive ali sinistre, ma anche e soprattutto il PCI. Infatti questo nuovo disegno configura un nuovo significato del tradizionale anticomunismo del mondo cattolico: il PCI non è più avversato principalmente per la sua collocazione filosovietica o per i pericoli che esso può rappresentare per i valori liberali e democratici del Paese, ma perché ritenuto strutturalmente incapace di esprimere compiutamente la volontà riformatrice espressa dal movimento dei lavoratori. Per attuare il suo progetto Labor si fa promotore di un nuovo soggetto politico culturale, l'Associazione di cultura politica (ACPol), che si costituisce l'8 marzo 1969 e che pubblicherà ACPol Notizie dall'ottobre dello stesso anno. Tra i promotori figurano esponenti aclisti, come Morezzi e Acquaviva, esponenti della corrente DC di Forze Nuove, dell'area socialista, come i lombardiani Signorile, Cassola e Cicchitto e i demartiniani Tempestini e Bartocci, oltre a dirigenti sindacali della CISL e giovani provenienti dal movimento studentesco. Labor non fa formalmente parte del gruppo promotore, in quanto ancora presidente delle ACLI, ma, come riconosce anche La Civiltà Cattolica, “ne è stato il vero creatore”. (Nasce l'ACPol, in «La Civiltà Cattolica», 1969, n. 2, pp. 80-84, alla p. 80). Anche il leader di Forze Nuove, Carlo Donat-Cattin, che non risulta tra i firmatari del manifesto costitutivo, nel Consiglio nazionale della DC del 25 febbraio aveva espresso per la preannunciata iniziativa “un naturale e personale consenso.” (ivi). Durante il periodo della sua esistenza, l'ACPol organizza alcuni convegni, il primo a Grottaferrata (Roma) il 30 e 31 agosto, poi a Milano, nel settembre 1969, su Contestazione sociale e movimento operaio; a Roma, nel novembre del medesimo anno, sulle Regioni; uno a Parigi, nel febbraio 1970, in collaborazione con il movimento francese Objectif '72, animato da cattolici di sinistra e sindacalisti della CFDT, su Strategia e prospettive della sinistra europea, a cui partecipano anche Carniti e Macario; e infine, nuovamente a Milano, nel marzo 1970, su Lotte politiche di base. Promotore di tali convegni è costantemente Livio Labor, affiancato inizialmente da Riccardo Lombardi. Al convegno di Parigi partecipa anche Lelio Basso, allora presidente dimissionario del PSIUP. Dal punto di vista formale l'ACPol vuol essere un luogo di confronto e di dibattito per pungolare i partiti esistenti e per sviluppare “un lavoro culturale che affronti i nodi fondamentali del sistema […e] struttura associativa che sia in grado, con la sua attività di approfondimento, di ricerca, di dibattito, d'iniziativa, di stabilire un rapporto con i movimenti reali del Paese, fuori da ogni prospettiva partitica ed elettorale.” ( Documento costitutivo dell'ACPol, 8 marzo 1969, in L. Labor, Scritti e discorsi, vol. 1, pp. 683-89, alla p. 689). Nelle intenzioni di Labor questa forma associativa costituiva solo un momento di passaggio verso la formazione di un partito democratico dei lavoratori da costituirsi non in tempi brevi (la scadenza naturale della legislatura era il 1973 e va ricordato che nella storia repubblicana non vi erano mai state fino ad allora elezioni anticipate). In effetti l'ACPol era anche formalmente una soluzione transitoria poiché prevedeva la possibilità della doppia tessera (cioè l'esser contemporaneamente soci della stessa e iscritti alla DC o al PSI o eventualmente ad altri partiti) e quindi non obbligava nessuno a scelte irreversibili. Secondo Labor anche gli aclisti che aderivano all'ACPol lo facevano a titolo personale senza coinvolgere il movimento, così come altrettanto facevano gli aclisti iscritti alla DC o alla CISL.
La fine del collateralismo: il congresso di Torino
Proprio per non compromettere le ACLI nella scelte dell'ACPol, Labor cerca di muoversi con molta cautela. Fin dalla fine di maggio del 1968 aveva comunicato a mons. Pagani che non intendeva continuare a fare il presidente, che auspicava “un congresso delle ACLI che sganciasse il Movimento da qualsiasi collateralismo, rilanciasse l'unità sindacale e decidesse di dare un apporto nuovo di tipo informale al coordinamento culturale e politico delle forze del cambiamento in Italia, in particolare delle forze di sinistra democratica. Occorreva […] che le ACLI si collegassero in un punto esterno al Movimento, che non lo coinvolgesse più direttamente nelle scelte politiche, e che corressimo il rischio «personale» di collaborare ad una profonda trasformazione del modo di fare politica in Italia.” (L. Labor, Non l'MPL ha fatto soffrire le Acli, in Scritti e discorsi, vol. 2, pp. 313-338, alla p. 317; lo scritto di Labor è pubblicato la prima volta in QAS, 1979, n. 6, pp. 105-140). Secondo la testimonianza dello stesso Labor, mons. Cesare Pagani avrebbe ben compreso il progetto di Labor e ne avrebbe compiutamente informato l'autorità ecclesiastica: “ Mons. Pagani innanzitutto dichiarò di aver comunicato e chiesto alla gerarchia se fosse opportuno trascurare un «cavallo» - disse – come la struttura delle ACLI. Affermò di aver parlato con mons. Andrea Pangrazio [segretario della CEI], con mons. Giovanni Urbani [presidente], con mons. Franco Costa [assistente dell'AC] e con Sua Santità Paolo VI. Osservava che la «rivoluzione», che si sentiva nell'aria, doveva essere animata cristianamente, che le ACLI erano profondamente presenti nel Paese, che c'erano tante inquietudini nel mondo cattolico […] I sacerdoti delle ACLI debbono impegnarsi […] per la formazione della coscienza cristiana dei lavoratori, dei militanti, dei dirigenti, questo chiedeva il Santo Padre.” Queste parole di Labor lasciano intendere una sorta di consenso condizionato sul suo progetto da parte della gerarchia, di cui mons. Pagani si faceva in qualche modo portavoce e tramite: “da milanese, egli capiva che magari era necessario anche questo nuovo aspetto d'impegno delle ACLI e sarebbe restato quale Assistente, anche con la compresenza di questo secondo aspetto di supplenza, per altri 5 anni. Egli richiedeva solo di venire sempre informato, che dessimo anche l'impressione esterna di essere dei cristiani purosangue e che questa interiorizzazione trasparisse. Ho con cura annotato che gli dissi «sì, noi dobbiamo tener presente tutto quanto Ella ci ha detto, non possiamo però accettare ancora l'11° comandamento, non avrai altro partito fuori di me, non possiamo far finta che il Concilio non ci sia stato e non possiamo non trarne le conseguenze anche per il modo in cui il nostro Movimento si muove nella lotta politica». Vorrei anche ricordare che il 30 giugno 1968 mons. Pagani persuase di quanto deciso in Presidenza padre Boschini e tutti i suoi Assistenti. Padre Boschini era riluttante, tutti gli altri accettarono.” (Ivi, vol. 2, p. 318).
In questo contesto di rapporti, Livio Labor si presenta al Consiglio nazionale del 15 febbraio 1969 annunciando l'intenzione di non ricandidarsi per la presidenza e chiedendo di anticipare di qualche mese la convocazione dell'XI congresso nazionale. Tale richiesta è contestuale ad una serie di proposte che la presidenza nazionale s'impegna a portare e sostenere in congresso. In particolare Labor indica il superamento di ogni collateralismo, l'affermazione del principio del voto libero degli aclisti, la presa d'atto della nuova domanda politica di cambiamento che emergeva dalla società e dalle lotte dei lavoratori e un rinnovato impegno per l'unità sindacale basata sull'autonomia e la partecipazione. (VCN, in ASA, Serie organi statutari, b. 8, fasc. CN del 15-16 febbraio 1969). Relativamente a come attrezzarsi di fronte alla nuova domanda politica che emerge dal Paese, Labor afferma: “Come dunque possiamo non auspicare che una liberazione del movimento da qualsiasi subordinazione dai partiti non possa rappresentare un grande fatto positivo? Ritengo che questa liberazione non possa attuarsi solo per un atto di volontà del nostro movimento, ma possa venire facilitata se qualcosa di autonomo e distinto si muoverà nel Paese, nel tentativo di dar capacità di autocoordinamento, di offrire concrete modalità di elaborazione di una nuova sintesi politica, alle molteplici forme del cambiamento.” (AS, 23 febbraio 1969, pp. 18-22). Tutto ciò nella convinzione che le ACLI “hanno camminato in questi anni con una sempre crescente coscienza della necessità di cambiare il sistema economico sociale capitalista.” Tutto il gruppo dirigente concorda con la linea Labor, salvo qualche isolato dissenso: Giovanni Bersani accusa il presidente di “far partire un treno nella nebbia” (Ivi, p. 24) e ribadisce di non esser d'accordo con “chi afferma che convenga rischiare il tutto per tutto; noi non siamo un club che può gestire come vuole cose di sua proprietà: noi abbiamo la responsabilità di portare avanti una tradizione”.
Il 19 giugno 1969, Livio Labor apre ufficialmente l'XI Congresso nazionale a Torino, che vede la partecipazione di ben 15 delegazioni estere e la presenza di autorevoli dirigenti sindacali, come Armato e Scalia della CISL, Garavini e Tatò della CGIL, Benvenuto della UIL, nonché esponenti nazionali di DC, PSI e PCI. Anche la stampa è presente in massa, con ben 66 giornalisti accreditati. Il presidente nazionale uscente, con una lunga relazione, cerca di spiegare compiutamente il senso della svolta proposta. In primo luogo è confermata la convinzione che sia ormai matura la prospettiva di una società alternativa a quella capitalistica, società che già nel titolo del congresso è definita come “nuova società del lavoro”, che le ACLI intendono contribuire a realizzare: “La nuova società che intendiamo costruire sarà del lavoro, se od in quanto si presenterà come il risultato di un nuovo, articolato associazionismo popolare. Siamo ben lontani dall'immaginare che per risolvere i mali della società italiana basti un nuovo partito […] C'è bisogno invece di un ritiro di deleghe in bianco ai partiti, a tutti i partiti, anche con seguito elettorale e popolare. […] Ogni spazio, ogni margine di partecipazione […] va difeso e conteso: non per fare polemica verso i partiti, ma per un corretto sviluppo della dialettica civile.” (L. Labor, Relazione introduttiva all'XI Congresso nazionale, in AS, 29 giugno 1969, p. 4). Il presidente uscente ricorda più volte che l'azione sociale del movimento non può essere disgiunta dall'ispirazione cristiana delle ACLI, che sono cristiane “nella natura stessa del loro impegno formativo”. Tuttavia sente il dovere di precisare la natura del rapporto che lega le ACLI alla comunità ecclesiale: “Una attenta considerazione delle positive evoluzioni dell'ecclesiologia post-conciliare non consente di credere che le ACLI possano, in conseguenza della loro natura cristiana, vantare investiture ufficiali o titolo di rappresentanza esclusiva dei lavoratori cristiani, di tutti i cristiani lavoratori d'Italia. La loro esperienza si qualifica come un'esperienza volontaria, maturata con rischiosa e responsabile sperimentazione, nel difficile campo del movimento operaio. La validità della loro testimonianza cristiana si misurerà dalla sua concreta efficacia e fedeltà, e non tanto da caratteristiche esteriori e formali.”
Ampio spazio nella relazione introduttiva è ovviamente dedicato a spiegare la scelta del voto libero degli aclisti, che all'opinione pubblica appariva come la svolta più dirompente e capace di mutare significativamente gli equilibri politici nazionali: “La fine del collateralismo con la DC è e deve essere una scelta permanente e irreversibile del movimento operaio cristiano. Ciò significa - e valga una volta per tutte questa precisazione – che non s'immagina, non si vuole e non si deve in alcun modo decidere che la rottura di un collateralismo implichi la creazione di un analogo rapporto in direzioni diverse, magari di segno divergente.” L'arcivescovo di Torino, card. Michele Pellegrino porta al congresso un caldo saluto, molto incoraggiante e lusinghiero: “La vostra presenza è richiamo e stimolo alla Chiesa torinese che sta cercando, con sforzo sincero e generoso, non senza incertezze e difficoltà, di attuare una pastorale che risponda effettivamente alle istanze che il mondo del lavoro pone alla comunità cristiana. Perciò il breve saluto che ho il dovere e la gioia di rivolgervi […] vuole essere l'espressione del riconoscimento dell'opera vostra, del ringraziamento da parte dei pastori e della comunità tutta, della fiducia con cui guardiamo al vostro lavoro di domani, che la svolta rappresentata da questo congresso è destinata a rendere sempre più consapevole e fruttuoso.” (AS, 29 giugno 1969, p. 21).
Dal dibattito congressuale emerge con evidenza un'adesione quasi plebiscitaria all'impostazione di Labor, alla quale si contrappongono alcuni interventi di una piccola minoranza interna: Enzo Auteri, secondo cui il congresso il congresso si è caratterizzato “per la sua preparazione nettamente di vertice” e le tesi proposte non sono “certamente espressione di tutto il movimento”; Giovanni Bersani, che avverte “il pericolo di scivolare su schemi di un classismo superato”; Michelangelo Dell'Armellina, che accusa il gruppo dirigente di aver attuato “una progressiva politicizzazione del movimento, sfociata negli ultimi mesi […] nel lancio dell'ACPol.” Emilio Gabaglio, successore designato da Labor, precisa meglio il tema dell'ispirazione cristiana delle ACLI, sostenendo che “il nostro impegno deve essere quello di contribuire a sanare la frattura sopravvissuta per troppo tempo tra religione e mondo operaio; frattura fatta forse meno di ostilità che di indifferenza, disinteresse, disattenzione, ma rispetto alla quale il mondo cattolico poco o nulla ha fatto – se non attraverso la presenza delle ACLI – per dimostrare nei fatti che non vi è contraddizione tra l'essere dei cristiani vivi e consapevoli e l'essere dei militanti che lottano per gli obiettivi di libertà e dignità e progresso della classe lavoratrice.” Le parole di Gabaglio sembrano essere in totale sintonia con quelle dell'assistente mons. Cesare Pagani, laddove afferma che la politicizzazione delle ACLI e la loro “accentuata autonomia” rivendicata dal congresso sono “due traguardi della lunga marcia che il mondo del lavoro e il movimento operaio stanno realizzando per raggiungere la meta di un vero umanesimo planetario”. Totale è anche l'adesione di Pagani alla collocazione delle ACLI nel mondo cattolico prospettata dal congresso, poiché esse “non possono non affermare la loro autonomia da organismi e orientamenti esterni alla loro vita, e quindi sovrapposti alla libera ricerca di verità nel mondo del lavoro.” Mons. Pagani approva anche la linea favorevole ad un maggiore impegno politico delle ACLI, che sarà oggetto di tante critiche del mondo cattolico nei mesi successivi: “Se ho capito bene le ACLI degli Anni '70 non potranno non intensificare la loro tipica politicizzazione perché intendono approfondire e allargare il loro patrimonio di vita culturale, di testimonianza vitale, di tesori spirituali ed umani, d'impegno per l'umanizzazione del mondo del lavoro.” (Ivi, p. 13).
La mozione finale approvata a larghissima maggioranza, col voto favorevole dell'86% dei delegati, dall'XI Congresso nazionale di Torino riassume efficacemente i contenuti di una svolta storica, sia per quanto concerne la valutazione della situazione politica, sia soprattutto per la dichiarata e irreversibile fine del collateralismo. Sul primo aspetto la mozione afferma: “La lotta dei lavoratori a partire dalla fabbrica e la protesta giovanile, a partire dall'università e dalla scuola, hanno maturato una presa di coscienza della necessità di profonde trasformazioni di un sistema che mortifica la condizione umana. […] A queste lesioni profonde – in cui molti individuano una nuova domanda politica – è finora mancata una adeguata risposta. Il progressivo esaurirsi della spinta innovatrice del centro sinistra e il sistematico svuotamento delle proposte di pianificazione hanno sminuito la portata degli interventi settoriali pur realizzati e disatteso i grandi impegni di riforma” (Ivi, p. 28). Di fronte a questa situazione le ACLI affermano la loro funzione insostituibile, confermano che il loro metodo consiste nella formazione, nel dialogo, nella “mobilitazione collettiva” e nell'azione sociale. La mozione finale del congresso è altrettanto chiara e risoluta sul tema della fine del collateralismo: “L'XI Congresso coerentemente con l'approfondimento progressivamente maturatosi della fisionomia delle ACLI e della loro originari funzione, constata la fine della pratica del collateralismo nei confronti di qualsiasi partito, come affermazione di piena e completa autonomia. Conseguenza di ciò è l'acquisizione del principio del voto libero degli aclisti, come espressione di fiducia nei lavoratori, nella loro capacità di compiere scelte personali coerenti con i valori in cui credono e con il messaggio delle ACLI. Con questa scelta di autonomia le ACLI si mettono nella condizione migliore per instaurare con tutte le forze partitiche un libero rapporto di critica e di proposta, e di sollecitare, così, una loro presa di coscienza nei confronti delle istanze sociali in continua evoluzione. Il congresso ritiene che queste decisioni pongano importanti premesse per l’intensificazione dell’impegno aclista dei lavoratori e dei cittadini, sui problemi politici e amministrativi a tutti i livelli. Si tratta di un impegno diverso da quello dei partiti nella collocazione e nella modalità, cioè un azione di ricerca, di critica, di proposta, di pressione e di mobilitazione di base coerente con l’ispirazione operaia e cristiana delle ACLI.” (Ivi, p. 29).
Il nuovo Consiglio nazionale delle ACLI, nel quale trovano posto solo tre parlamentari (Pozzar, Foschi e Russo), è espressione della linea politica di Labor, con una maggioranza schiacciante (70 seggi su 82). L'opinione pubblica è ben consapevole dell'importanza della svolta voluta dal congresso e lo testimoniano gli articoli e i commenti, molto copiosi, della stampa del tempo. Si può comunque osservare che la fine del collateralismo può essere interpretata sia come un punto di arrivo, sia all'opposto come un punto di partenza. Dal primo punto di vista, fatto proprio verosimilmente dai numerosi delegati iscritti o comunque tradizionalmente elettori della DC, che pur insoddisfatti dell'incapacità del partito di attuare una radicale strategia riformatrice funzionale alle speranze del mondo del lavoro, credevano ancora nella possibilità di mutare gli equilibri interni del partito cattolico. Per loro il pluralismo delle opzioni politiche consentiva alle ACLI di mantenere una sostanziale unità d'intenti al di là delle differenziazioni individuali al momento del voto, valorizzando il ruolo educativo e formativo del movimento, la funzionalità e l'efficacia dei servizi, la possibilità di favorire il processo d'unità sindacale e di offrire momenti di dialogo e di confronto tra tutte le tendenze politiche del mondo del lavoro in virtù della propria collocazione partiticamente neutrale o super partes. Non solo, gli aclisti attivamente impegnati nella DC, alcuni anche ad altissimi livelli di responsabilità, come Vittorino Colombo, erano convinti che la scelta della libertà di voto potesse influenzare in positivo il partito, costringendolo a guadagnare sul campo il consenso dei lavoratori cattolici, in precedenza scontato, attuando una politica economica e sociale meno liberista e più favorevole alle esigenze dei lavoratori. All'opposto la gran parte dei dirigenti aclisti vicini a Labor, pensava che il pluralismo delle opzioni politiche fosse il primo passo per potenziare il ruolo politico delle ACLI, nel senso di essere conseguenti alla consapevolezza della necessità di creare una nuova forza politica democratica, espressione diretta e unitaria del mondo del lavoro, la cui costituzione era lasciata alla scelta personale dei militanti, ma di cui le ACLI dovevano in qualche modo preparare un retroterra sociale e culturale che favorisse il confronto e la convergenza di componenti politiche schierate al momento in partiti diversi. Come si è visto, la presenza significativa di dirigenti democristiani di Forze Nuove, della sinistra socialista e di esponenti di rilievo della CISL al momento della costituzione dell'ACPol lasciava presagire buone possibilità di operare in tal senso, e proprio per questo Labor aveva lasciato la presidenza nazionale delle ACLI e aveva deciso di impegnarsi a dirigere tale nuovo progetto.
Una settimana dopo il congresso delle ACLI, Flaminio Piccoli, segretario nazionale della DC, aprendo a Roma l'XI congresso nazionale del partito, polemizza duramente con le scelte acliste, con un tono quasi sprezzante: “Cari amici, in questi giorni il nostro partito è stato indirettamente coinvolto nel dibattito di una grande ed importante organizzazione cattolica, le ACLI. Quella che è stata definita una svolta è stata motivata con la volontà di porre fine al collateralismo, nel senso che gli iscritti alle ACLI hanno inteso affermare tutt'intera la loro libertà di scelta politica: una collateralità che, a dire il vero, noi non abbiamo mai chiesto come partito politico; una libertà di scelta e di voto che è sempre rimasta intatta, anche perché le scelte delle ACLI sono sempre state fatte non per pressioni della DC, ma per espliciti, aperti, onesti orientamenti dei loro dirigenti, sulla base di convincimenti meditati e pubblicamente chiariti. […] Ci siamo rammaricati delle espressioni che sono state rivolte alla DC […] Ci sarebbe soltanto da chiedersi: se a monte di tutte le iniziative del mondo cattolico, a monte quindi anche delle ACLI, non ci fosse stata e non ci fosse l'iniziativa della DC col suo patrimonio di libertà […] dove sarebbero le ACLI?” (Relazione di Flaminio Piccoli all'XI congresso nazionale della DC, Roma 27 giugno 1969, in V. De Marco, Fede e politica nelle relazioni dei segretari della DC, 1946-1986, Morcelliana, Brescia 1989, pp. 98-100). Il segretario della DC concludeva criticando le ACLI per essersi snaturate, appellandosi implicitamente alla gerarchia: “Non crediamo nostro diritto interferire nella vita interna delle ACLI, se non per un giudizio di valore […] sull'ambito in cui l'organizzazione cattolica dovrebbe operare, secondo le ufficiali dichiarazioni della gerarchia: ambito definito in un recente documento, come quello di «un'associazione di laici che operano nel senso dell'azione pastorale e della fermentazione cristiana delle realtà terrestri, per la effettiva promozione dell'uomo alla luce della Rivelazione e del magistero della Chiesa». Ci limitiamo a constatare che le ACLI, anche a questo congresso, hanno rivelato prevalenti interessi, orientamenti e propositi di esplicito intervento politico […].”
Oltre a questa dimensione prettamente politica, non va poi dimenticato il clima culturale molto acceso e magmatico nel quale si svolge il congresso delle ACLI di Torino, dopo un anno di accese lotte studentesche, alla vigilia dell'autunno caldo, col mondo cattolico in fermento. Tra le tante testimonianze personali di chi ha vissuto quell'esperienza, particolarmente significativa, anche per il suo ruolo nelle ACLI, è quella di mons. Pagani: “C'era ovunque il mito dell'analisi marxista; dalla politica si aspettava la soluzione di quasi tutti i problemi; l'ideologia dell'«alternativa» penetrava le menti più fervide; gli obiettivi più utopistici sembravano a portata di mano; rifiuto di qualsiasi delega; scelta di campo; ecc. Nelle ACLI molti avvertivano il fascino carismatico dei capi e credevano alla potenza «dirompente» - questo era il linguaggio! - del «milione» di iscritti, all'influsso delle manifestazioni che facevano notizia sulle colonne dei giornali. L'interessata simpatia di molti sindacalisti e di uomini politici di sinistra completava il quadro. Anche dalle vulcaniche e molteplici esperienze di comunità e di gruppi cattolici venivano vivaci stimolazioni e provocazioni. Il Concilio sembrava fatto su misura per sospingere i laici verso dialoghi sempre più rischiosi, verso impegni sociali sempre più intensi e innovatori; i «segni dei tempi» sembravano indicare strade smisuratamente aperte; la collegialità sembrava imporre nella Chiesa una radicale revisione della dimensione «gerarchica» e del rapporto con il Magistero ecclesiastico; non mancavano certo i teologi che garantivano la giustezza dei ragionamenti più azzardati. In nome di queste sollecitazioni «conciliari» molti si entusiasmavano per la fine del «mondo cattolico» o per il tramonto dell'« era costantiniana" o per lo svuotamento della identità specifica del cristiano. Alcuni richiamavano il dovere missionario di liberare le masse cattoliche dai tabù di una esasperata sacralizzazione, dal potere clericale, dalle incomprensioni verso la classe operaia, ecc. Per obiettività bisogna ricordare il fervore, l'entusiasmo, l'evidente passione di moltissimi giovani e di molti adulti che vibravano di speranza; e, soprattutto, bisogna ricordare che quasi tutti gli ambienti cattolici, i movimenti, le associazioni, i gruppi più impegnati, sentivano profondamente il tormento della contestazione.” (C. Pagani, Il congresso di Torino dieci anni dopo, in «Aggiornamenti Sociali», 1979, pp. 801-12, alla p. 806).
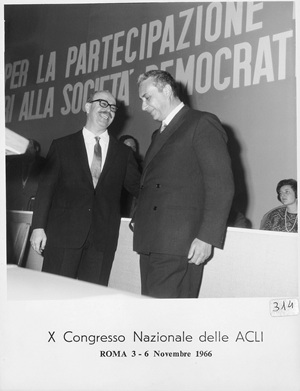
(Abbreviazioni: AS = Azione Sociale, periodico delle ACLI; ASA = Archivio storico delle ACLI nazionali; AO = Acli Oggi; QAS = Quaderni di Azione Sociale; VCN = verbali del Consiglio Nazionale)
Principali scritti di Livio Labor (1918-1999):
-
Scritti e discorsi, a cura di C. F. Casula, M&B, Milano 2003,
2 vol. di pp. 763 e 482, comprende articoli su giornali e riviste, relazioni a
congressi e convegni e interventi pubblici, ordinati cronologicamente dal 1948
al 1998.
- Sindacalismo e socialità, Ateneo, Roma 1950
- Il movimento operaio cristiano in Italia, Edizioni ACLI, Torino 1957.
- In campo aperto, Nuova Italia, Firenze 1969.