Franco Manni
Il dibattito sulla natura della filosofia
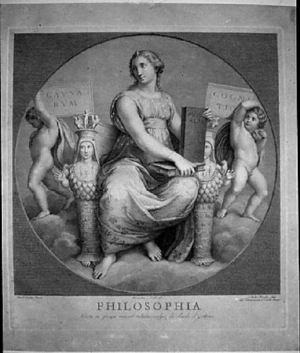
Temi
e Problemi
-
argomento
del Corso.
è diffusa l'idea che esista la
filosofia, varie espressioni del linguaggio comune lo testimoniano. Però su
cosa essa sia c'è molta meno diffusa chiarezza tra i profani. È
una Visione del Mondo? è una Via di Salvezza per la vita? è una
Tecnica Logica e Retorica? è un'Astrusa Erudizione? Tra gli specialisti
della filosofia non c'è - invece - mancanza
di chiarezza, nel senso che ciascun filosofo ha chiaro cosa per lui sia la
natura e il compito della filosofia; però c'è grande molteplicità di
convinzioni: non tutti la pensano allo stesso modo! C'è (da millenni e
ancora oggi) un dibattito!
-
alcune
definizioni di filosofia
prese da classici del pensiero filosofico. Voi corsisti provate a leggerle e
a stilare una classifica tra esse, in base alla vostra attuale opinione su
“cosa è” la filosofia.
-
la
conoscenza scientifica.
Essa si diversifica secondo i tempi e secondo i settori di studio. Una delle
sue caratteristiche è la specializzazione
(si insegnano le “scienze” e non la “scienza”),
e in essa risiede la sua potenza assieme alla sua esotericità . Per quanto
cresca l'istruzione media in una società ed esistano buone agenzie di
divulgazione scientifica, questa conoscenza rimane quella dell'Esperto: la
persona “profana” difficilmente discute gli asserti del fisico e del
biologo, ma anche quelli dell'economista, del costituzionalista e dello
psicologo. Li prende come verità su cui non potere dire la propria. Questo
ostacolo alla discussione deriva della non comprensione che qualsiasi
scienza è prodotta non solo dalla mole delle nozioni empiriche particolari,
ma anche dai suoi presupposti teorici
che sono cambiati molto e continuamente proprio a causa di discussioni, e
che impostano la ricerca dei particolari empirici e ne danno il senso.
-
la
conoscenza del “senso comune”.
Questo varia secondo le aree nazionali e secondo i tempi, però esiste. Tra
le sue caratteristiche: la socialità e la dogmaticità. Esso si esprime
esplicitamente con le leggi, coi “luoghi
comuni” e coi proverbi, e implicitamente coi comportamenti socialmente
diffusi che sono, sì, abitudini di azione, ma derivanti da idee o meglio
“ideologie” (sistemi di idee) presupposti all'azione e, di solito,
inconsapevoli. Un filosofo come Socrate è simbolo di una funzione della
filosofia: la “critica” (messa in discussione) del senso comune.
Discutere non significa per forza confutare, e la filosofia può
confutare, può analizzare e può anche giustificare un luogo comune.
Facciamo tre esempi: 1) “il mondo era migliore Una Volta”; 2) “tutto
è relativo”; 3) “il mondo è bello perchè è vario” . è una delle
sfide della filosofia: Benedetto Croce diceva che il “Non-filosofo” (il
portatore del senso comune) è il “figlio del Filosofo”, nel senso che,
se una filosofia è valida, essa si deposita nel senso comune come una delle
sue varie componenti.
-
la
conoscenza religiosa. Essa ha in comune con la filosofia molti temi
(l'origine dell'universo, i vizi e le virtù, lo scopo della vita umana
ossia la ricerca della felicità, l'organizzazione della società,
l'esistenza e la natura di Dio), e per questo a volte viene confusa con
essa: Budda era un profeta o un filosofo? E il “teologo” che parla di
bioetica al talk show televisivo in che senso si distingue da un
“filosofo” che fosse stato invitato dal conduttore
lui al posto suo? Eppure
ha un metodo diverso perchè si basa non sulla diretta esperienza e sulla
logica, ma sulla “fede” e cioè su una delega dell'esperienza a qualcun
altro, e cioè il profeta che rivela la verità religiosa e la comunità dei
credenti che la tramanda.
-
la
conoscenza artistico-letteraria.
Assieme alla religione è una dei modelli più popolari di conoscenza:
Shakespeare, Manzoni, Omero, Dante, Leonardo da Vinci, Picasso, Simon e
Garfunkel, Giuseppe Verdi sono certo “maestri” riconosciuti dal
popolo più di quanto lo siano Platone, Cartesio o Kant. Essa ha la
potenza della immagine sensibile (Amleto dubbioso, Ulisse e i Proci,
Guernica distrutta, il sorriso della Gioconda, Don Abbondio e i Bravi, i
gironi infernali, la passeggiata notturna nel silenzio), e funziona come
“esempio” (di personalità morali, di scenari di azione, di paesaggi, di
sentimenti): la propria esperienza viene interpretata anche nel confronto
con l'esempio.
-
Il
percorso storico:
sin dagli inizi della storia della filosofia, e cioè nell'Antichità greca,
il ruolo della filosofia è stato praticato e anche teorizzato in maniere
differenti. I Fisici presocratici hanno voluto spiegare soprattutto i
fenomeni naturali, Socrate e i Sofisti criticare le convenzioni morali della
loro epoca, Platone indicare le vie di conoscenza per organizzare uno Stato
ideale e per sperare nell'immortalità, Aristotele sistemare tra di loro
tutte le scienze, Stoici ed Epicurei dare una guida per la vita quotidiana,
i Neoplatonici speculare su Dio. E poi via via nelle epoche successive fino
ad oggi...Anche oggi convivono filosofi che pensano la filosofia come
Analisi del Linguaggio, con chi la pensa Speculazione sull'Essere, con chi
la pensa Messaggio Esistenziale, con chi la pensa Metodologia delle Scienze
Naturali, con chi la pensa Utopia Politica...
-
piano
del Corso.
Dopo alcune lezioni di storia della filosofia, affronterò i confronti tra
la conoscenza filosofica e le altre quattro conoscenze sopra delineate.
Alcune
definizioni di “filosofia”
È
a causa del sentimento della meraviglia che gli uomini ora, come al
principio, cominciano a filosofare.
[Aristotele,
IV sec. a. C.]
Se
si deve filosofare, si deve filosofare e se non si deve filosofare, si deve
filosofare; in ogni caso dunque si deve filosofare. Se infatti la filosofia
esiste, siamo certamente tenuti a filosofare, dal momento che essa esiste;
se invece non esiste, anche in questo caso siamo tenuti a cercare come mai
la filosofia non esiste, e cercando facciamo filosofia, dal momento che la
ricerca è la causa e l'origine della filosofia.
[Aristotele,
IV sec. a. C.]
Meneceo,
mai si è troppo giovani o troppo vecchi per la conoscenza della felicità.
A qualsiasi età è bello occuparsi del benessere dell'animo nostro. Chi
sostiene che non è ancora giunto il momento di dedicarsi alla conoscenza di
essa, o che ormai è troppo tardi, è come se andasse dicendo che non è
ancora il momento di essere felice, o che ormai è passata l'età. Ecco che
da giovani come da vecchi è giusto che noi ci dedichiamo a conoscere la
felicità. Per sentirci sempre giovani quando saremo avanti con gli anni in
virtù del grato ricordo della felicità avuta in passato, e da giovani,
irrobustiti in essa, per prepararci a non temere l'avvenire. Cerchiamo di
conoscere allora le cose che fanno la felicità, perché quando essa c'è
tutto abbiamo, altrimenti tutto facciamo per possederla. Pratica e medita le
cose che ti ho sempre raccomandato: sono fondamentali per una vita felice.
/.../ Perché non sono di per se stessi i banchetti, le feste, il godersi
fanciulli e donne, i buoni pesci e tutto quanto può offrire una ricca
tavola che fanno la dolcezza della vita felice, ma il lucido esame delle
cause di ogni scelta o rifiuto, al fine di respingere i falsi
condizionamenti che sono per l'animo causa di immensa sofferenza. Di tutto
questo, principio e bene supremo è l'intelligenza delle cose
[Epicuro,
IV sec a. C.]
La
filosofia non respinge né preferisce nessuno: splende a tutti.
[Seneca,
I sec. d. C.]
La
superstizione mette il mondo intero in fiamme, la filosofia le spegne.
[Voltaire,
XVIII sec.]
Non
c'è da attendersi che i re filosofeggino o che i filosofi diventino re, e
neppure è da desiderarlo, perché il possesso della forza corrompe il
libero giudizio della ragione. Ma che un re o un popolo sovrano non lascino
ridurre al silenzio la classe dei filosofi, ma la lascino pubblicamente
parlare, è indispensabile agli uni e agli altri per avere luce sui loro
affari.
[Immanuel Kant, XVIII sec.]
La
filosofia è il proprio tempo appreso col pensiero.
[Georg
Wilhelm Friedrich Hegel, XIX sec.]
Che
cosa rende filosofi? Il coraggio di non serbare alcuna domanda nel cuore
[Arthur
Schopenauer, XIX sec.]
Credo che ci sia un solo argomento a difesa dell'esistenza della
filosofia. È questo: lo sappiano o no, tutti gli uomini hanno una
filosofia. Certo, può ben darsi che nessuna delle nostre filosofie valga un
gran che, ma la loro influenza sui nostri pensieri e sulle nostre azioni è
grande, e spesso incalcolabile.
[Karl
Popper, 1902-1994]
Cos'è
la filosofia? Scusate il mio conservatorismo banale, ma non trovo ancora di
meglio che la definizione che ne dà Aristotele nella Metafisica:
è la risposta a un atto di meraviglia.
[Umberto
Eco, nostro contemporaneo]
Profilo
storico:l'Età Antica
-
dal Mithos
al Logos: il naturalismo dei
Presocratici e la polemica contro i “poeti teologi”. Quale
collegamento con il nostro vissuto? i
tre racconti mitici su origine dell'universo
in Kereny pp. 21-24 ;
Berti sulla meraviglia pp. V, VI, IX, X …; Berti pp. 76-77 su filosofi
contro teologi e poeti...; letture di Presocratici da Gianotti pp. 40-42,
146, 147, Cambiano pp. 125, 128, 129, Eraclito pp. 9, 11, 21, 33, 37, 39,
41, 43....esercizio ai corsisti: immaginate un mito della nostra epoca di
tipo religioso e/o politico e come potremmo polemizzare come facevano
Eraclito, Senofane, Anassagora ecc.
-
nei
Sofisti (Gorgia, Protagora, Ippia, Prodico di Ceo) la filosofia è intesa
come “retorica” e cioè scienza della persuasione efficace di una
“credenza” e non di una “scienza”......Gorgia
pp. 157-161 … il sofista Callicle nel Gorgia
di dice che essa va bene per i ragazzi (per abituare dunque a “persuadere
credenze” nelle cose più importanti come il bene della persona e della
comunità (non quelle speciali come le altre scienze) … ma poi quando i
ragazzi crescono al filosofia diventa ridicola perchè questa funzione è
molto meglio svolta dalla retorica dei politici ...ecco perchè la filosofia
deve esser retorica: Paolinelli Le ragioni del filosofare pp. 35-39 quasi che ai ragazzi si potesse contrabbandare la
ricerca del Vero come se fosse la ricerca della persuasione (del successo,
l'unica cosa seria) mentre agli uomini cresciuti no...dunque – conseguenza
logica – anche ai ragazzi già si potrebbe insegnare solo la ricerca della
persuasione (del successo)
-
Socrate e
la filosofia come “critica dei luoghi comuni”: Egli come
“tafano” o “torpedine” degli Ateniesi. Queste critiche sono
“paradossi”, per es. : “sapiente è chi sa di non sapere”,
“nessuno fa il male volontariamente”, “per conoscere sé stesso bisogna interrogare gli
altri”, “è più fortunato chi subisce un'ingiustizia rispetto a colui
che la fa”, “insegnare non è trasmettere idee, ma farle
partorire”.Quale collegamento con il nostro vissuto? Cfr.
dialoghi socratici : “sapiente è chi sa di non sapere” (Apologia
pp.43-44), “insegnare non è trasmettere idee ma farle partire” (Teeteto),
“nessuno fa il male volontariamente” (Protagora
p. 135) “è meglio subire l'ingiustizia piuttosto che farla” (Gorgia),
“per conoscere sé stesso bisogna interrogare gli altri”; esercizio ai
corsisti: immaginate un luogo della vostra vita analogo ai ginnasi
di Socrate e pensate a come una persona (voi o altri) possa svolgere
il ruolo socratico
-
il
pessimismo politico ed
esistenziale di Platone e la ricerca di un Aldilà metafisico e di
un'Utopia politica. Quale collegamento con il nostro vissuto?
Il Fedone (per l'al di là –
vedi berti 142, 316) e la Repubblica
(utopia) di Platone e il Simposio
per il pessimismo sull'amore....; .... esempi attuali: a) per al di là: extraterrestri new age e i corpi spirituali di
ispirazione orientale, certi vissuti di anziani delusi e l'idea che la vita
è finita e che devono solo ricongiungersi coi cari defunti, certi giovani
che con le tendenze suicidarie immaginano che la propria presunta
“purezza” sia salvata dal “mondo crudele” che non li capisce;
b) per l'utopia la rivoluzione
marxista e quella fascista e berlusconiana
-
la visione
di una società complessa da parte di Aristotele e la ricerca di una Completa
Sistemazione di tutti i tipi di conoscenza. Quale collegamento con il
nostro vissuto? Paolinelli
Le ragioni del filosofare (p. 41): non bastano le conoscenze
speciali slegate tra di loro; ecco che bisogna veder che le varie conoscenze
sono finalizzate alla felicità e allora è necessaria una conoscenza rectrix che le ordini, la sapienza (117), questa sapienza è dunque
architettonica ed è “la saggezza dell'uomo” nel senso che per quegli
animali che siamo noi nella società complessa che abbiamo costruito con le
nostre scienze e tecniche è saggio conoscere i principi delle scienze e il
loro ordine e connessione (125)... Berti , In
principio era la meraviglia : d'altra parte la sapienza superiore alla
saggezza (273), che tipo di vita contemplativa ? Non quella del monaco ma
quella dello scienziato (284), l'ozio è legato alle leggi che lo permettono
(286): gli anni sessanta e l'innalzamento dell'obbligo scolastico, la
licealizzazione di tale obbligo....esempio culturale: nel XX secolo
Freud ha seguito questo modello aristotelico di filosofia trattando:
la medicina, la storia dell'arte, la antropologia preistorica, la
religione, la biologia evoluzionistica, la sociologia della massa.... Un
esempio dal mio vissuto: il fumo: biologia
e cancro, psicologia e modelli
imitativi e gestualità,diritto e
sociologia e le diverse norme nei
paesi esteri, etica e la teoria
della saggezze come scelta tra azioni individuali né tutto così né tutto
cosà, fisica e la volumetria dei
locali, chimica e le percentuali
di nicotina e catrame nella extralight, storia
e sociologia e le mode e i luoghi
comuni di adesso, ancora etica e
la non sottomissione agli altri altra faccia della medaglia del non
sottomettere gli altri... la filosofia (amicizia della sapienza) ordina le scienze verso il
sommo bene: risultato: se, cosa , quando, come perchè fumare
-
posizione
comune in Socrate , Platone e
Aristotele: per quanto con differenze tra di loro, essi si oppongono ai
Sofisti: la filosofia non è persuasione ai fini del potere né gioco
intellettuale ai fini della formazione delle mente o del piacere , ma è
essa stessa (la sapienza) l'atto della vita felice...non ha fine pratico
perchè essa è il fine Paolinelli
, Le
ragioni del filosofare
-
il
dovere di vigilare e lavorare nel qui e nell'ora
dello Stoicismo. Quale collegamento con il nostro vissuto?
Marco Aurelio...
-
la
ricerca della “serenità”
(atarassia): riconoscere la nostra
umile natura di esseri bisognosi nella individuazione dei piaceri minimi e
delle paure da ottenersi e delle paure massime di cui sbarazzarsi
nell'Epicureismo. Quale collegamento con il nostro vissuto?
Epicuro
Lettera a Meneceo... esercizio ai corsisti: cercate di compilare un
“tetrafarmaco” adatto agli uomini di oggi
-
la ricerca
della “serenità” e lo
“intellettualismo anti-intellettualistico”
dello Scetticismo: la decisione di sospendere il giudizio sulle
teorie degli scienziati e dei filosofi, nel mentre si seguono gli usi e
costumi prevalenti nella propria società. Quale collegamento con il nostro
vissuto? Cfr.
lo scettico Sesto Empirico e la sezione Accademica di Sulla natura degli Dei di Cicerone...
-
la ricerca
della “illuminazione” della gnosi del Neoplatonismo.
Quale collegamento con il nostro vissuto? parti
su Plotino nel Berti , capitoli
sugli Dei e su Immortalità e su Essere
Profilo
storico: Medio Evo, Età Moderna, Età Contemporanea
-
filosofia
come giustificazione della fede religiosa: Agostino
d'Ippona (V sec. d. C.), Tommaso d'Aquino (XIII sec.) , Henri De Lubac (XX
sec.)..
Paolinelli,
Le ragioni del filosofare ....e Summa
di Tommaso e Mistero di De Lubac come esempi della ragione che giustifica a
posteriori la fede...
-
filosofia
come racconto storico: il “sistema delle idee” è la “storia delle
idee” :
Bernardo di Chartres (XII sec.), Georg W. F. Hegel (1770-1831), Benedetto
Croce (1866-1952), Robin G. Collingwood (1889-1943) 1)
il pensatore pensa come “nano sulle spalle dei giganti” (Gilson ad
locum di Bertrando di Chartres) 2) Hegel : il sistema delle idee è la
storia del pensiero della umanità e l'individuo per imparare tale sistema
non deve pensare in astratto ma ripercorre gli snodi e problemi realmente
presentatisi nella storia (storia
della filosofia pp. 56-64 , e poi
Enciclopedia p . 21, poi Filosofia
della storia pp. 14-16); 3)
la filosofia è metodologia della storia: pagine segnate di Teoria
e storia di Croce...e poi magari la teoria del giudizio storico nella Logica
(vedi pagine segnate) … e 54-55 di Collingwood..... il modello concreto
anche qui è Freud nella psicanalisi..e qui potrei affrontare quel tipo di
pensiero che è la psicanalisi. In quale maniera si differenziano
psicanalisi e filosofia?... alla stessa maniera in cui lo fanno storia e
filosofia: facciamo un esempio storico: la prima rivoluzione inglese, o
anche la resistenza partigiana italiana.... facciamo un esempio
psicanalitico: la cosiddetta depressione... o anche un rapporto
interpersonale conflittuale...
-
filosofia
come metodologia delle scienze naturali:
Renée
Descartes (1596-1650), Moritz Schlick (1882-1936), Rudolf Carnap
(1891-1970), Karl R. Popper (1902-1994) 1)
Descartes e Popper hanno pensato alle scienze naturali come
modello di metodo per
le altre conoscenze, ma Descartes lo ha idealizzato perchè non ne conosceva
la storia, mentre Popper, che la conosceva, no!
2) Carnap e Schlick (pagine 69-70) hanno pensato alle scienze
naturali come l'unico pensiero e la filosofia il loro metodo...
-
filosofia
come critica e riforma della società:
Voltaire (1694-1778), Karl Marx (1818-1883)
-
filosofia
come creazione di mito:
Friedrich Nietzsche (1844-1900), Alfred Rosenberg (1893-1946), Herbert
Marcuse (1898-1979)
La
distinzione tra il sapere della filosofia e il sapere delle altre scienze
-
Scienza
e scienze. La filosofia come una particolare scienza. Scienze naturali e
scienze umane: il privilegio delle prime è dovuto a varie cause: 1) la
diversa complessità e dunque la pretesa della quasi-universalità, 2) il
tipo di civiltà post-medievale assai più interessato alla natura
extra-umana, 3) l'interferenza delle passioni negli “oggetti umani”
-
l'uomo
non ha intuizione astrattiva delle essenze specifiche, per es. “l'esser
rosso” (Galilei: “il tentar le essenze lo do per impossibile”), mentre
la ha delle essenze universali , per es. “essere” in CME ( Paolinelli, Contro
il Monismo epistemologico) p. 97...brano di Galilei in CME pp. 250-1....
Questo significa che ciò che possiamo conoscere dei corpi sono i rapporti
quantitativi con altri corpi, gli oggetti naturali sono definiti non da
qualità caratteristiche ma da rapporti in CME p. 143
-
Leibniz
(1646-1716) distinse due tipi di conoscenza, quello filosofico e quello
scientifico. La filosofia riguarda gli aspetti universali cioè
presenti in ogni ente (per es. essere, divenire, identità,
forma, materia, sostanza, causa, intelligibilità, appetibilità), le
scienze riguardano gli aspetti particolari
cioè propri solo di alcuni
enti CME p. 154, p. 166
-
Cosa
significa “particolari” (non individuali) ? Cosa significa
“universali” (non generali) ? Il passaggio dal “come” al “perchè”.
Cfr EdF (Sofia Vanni Rovighi, Elementi di Filosofia) pp. 28-29
-
Fu
la confusione tra scienza aristotelica e filosofia aristotelica a screditare
la seconda quando (XVI-XVIII sec.) fu screditata la prima CME p. 155 EdF p.
33
-
Leibniz
e la Teoria Ilemorfica di Aristotele come esempio di teoria
filosofica che permette meglio di un'altra, e cioè l'Atomismo Meccanicista,
di sviluppare le scienze naturali o, come ancora premeva a Leibniz,
“elevare lo spirito alla conoscenza delle nature incorporee e delle
meraviglie di Dio” CME p
152-153 . Cosa che cercò di fare Leibniz stesso nella sua Monadologia:
mostrare come la causa del fatto che conosciamo i particolari solo nelle
loro relazioni sia dovuto a un “essere-come-relazione” in cui la
conoscenza dell'altro-da-noi (il suo diverso ruolo nella “armonia
prestabilita”) è possibile solo nella relazione con esso,
“assediandolo” induttivamente (come fanno sia le scienze naturali sia le
scienza umane, in un “assedio” mai esaustivo, in una ricerca infinita)
mentre ciò che ci accomuna (il fatto che qualsiasi ente ha un ruolo
nella armonia prestabilita) è conosciuto immediatamente.
-
la
distinzione tra filosofia e scienze è necessaria, altrimenti esse si
potrebbero “intralciare”. Come si vede in alcuni libri di divulgazione
scientifica in cui c'è una varia mescolanza tra scienza autentica e falsa
filosofia EdF p. 29, p. 134 …. Si potrebbe
fare l'esempio di tanti manuali di biologia evoluzionistica, e
arrivare a dire che la distinzione serve a impedire che agiscano le false
filosofie, se si hanno in mente
quelle vere, o, detto con altre
parole, che mentre si studiano
i particolari , il nostro insopprimibile anelito verso una
“visione del mondo” ci fuorvii proprio nella consultazione
induttiva (nella relazione) coi particolari
-
Robin
G. Collingwood (1889-1943) e la “non falsificabilità” dei presupposti
filosofici, che sono però da descriversi, da rendere consapevoli. Essi
hanno una funzione positiva (e non solo negativa, come in quanto detto
prima): di guidare le linee di ricerca scientifiche. E il loro studio - la
filosofia - aiuta gli
scienziati nel renderli consapevoli di presupposti che magari accettano fino
a che sono inconsapevoli, ma potrebbero rifiutare quando ne diventassero consapevoli (An Essay on Metaphysics, pp. 54-55
-
Karl
R. Popper (1992-1994) e la “valutazione critica” delle filosofie (anche
se non “falsificabilità”)
-
Come
esempio, vediamo la fonte
(non la distorsione) filosofica di alcune scienze : 1) biologia
darwiniana (storicismo hegeliano), 2) psicologia freudiana (romanticismo),
3) giurisprudenza costituzionale (giusnaturalismo e illuminismo)
Conclusioni
-
Percorso
delle lezioni:
1)
presentazione del tema del corso e di due problemi connessi ad esso ( a.
i vari tipi di sapere: quale quello filosofico? ; b. ma i filosofi la pensano in maniera spesso diversa tra loro,
esempi di sentenze di filosofi famosi su cosa sia la filosofia); 2)
la filosofia come ricerca di un principio primo, simile alla religione, ma
diversa da essa perchè demitizzante, razionalistica 3)
i Sofisti e la filosofia come arte del persuadere, influenzare, comandare;
Socrate e la filosofia come critica dei luoghi comuni; 4)
Platone e la filosofia come fuga da questo mondo e scoperta di mondi
nuovi ed alternativi sia per l'individuo sia per la collettività 5)
Aristotele
e la filosofia come approccio razionale a tutti gli ambiti della conoscenza,
sia umani sia extra-umani (una specie di pre-freudismo; Agostino e la
filosofia come giustificazione razionale di ciò che prima si creduto; 6)
Agostino e il “crede
ut intelligas et intellige ut credas
7)
Hegel: la filosofia come storia della filosofia; Croce: la filosofia come
momento metodologico della storiografia;
8)
contro il monismo epistemologico: distinzione tra sapere filosofico e sapere
scientifico; 9)
stesso
argomento; 10)
conclusioni.
-
Un
buon ingresso alla filosofia:
il
vostro!: si potrebbe commentare come i percorsi con cui sono arrivati i
corsisti siano eterogenei... ci sia stato un passaparola di tipi diversi...
come né l'aspetto narcisistico né quello
opportunistico abbiano contato; e
questo favorisce lo scopo della filosofia!...
-
La
pervasività delle idee filosofiche:
parlo con un collega e vedo che lui preoccupato se nelle lezioni di Storia
gli insegnanti parlino o no delle foibe... ah, la potenza delle idee e della
cultura!, ma solo in senso profondo, veramente filosofico!... cioè quel
collega, foibe o non foibe, aveva assunto delle idee di fondo circolanti nella società italiana presente su
cosa sia la giustizia (essa dà ragione a chi nei fatti cioè visibilmente
ha il potere al momento presente nell'ambiente dove tu vivi) e cosa sia la
verità (essa qualcosa che legato da chi ha il potere ingiustamente, in un
mondo invisibile
-
I
mezzi della filosofia:
per filosofare ci vogliono i due materiali 1)
la
vita (da scomporre in : A.
osservazioni
empiriche; B.
reazioni
sentimentali a tali osservazioni; C.
pensiero
analitico sui tali reazioni; D.
pensiero
pratico di saggezza) e 2)
lo
studio (cioè la cultura,
cioè : A.
altri
pensieri pensati da
altri e per altri , o per
tutti, cioè le cosiddette teorie B.
i
fatti della vita e della storia nel senso di passato e cambiamento C.
i
fatti della storia nel senso di interrelazioni interpersonali e collettive). Quel collega, secondo me, mancava di entrambi i
mezzi della ricerca filosofica...
-
Filosofia
come dialogo euristico.
Cioè
come dialogo volto a scoprire, imparare (in greco, “eurisko= scopro, imparo), visto che ci sono molte altre tipologie di
dialogo o conversazione tra le persone: dialogo per passare il tempo; per
divertirsi; per vincere e avere ragione in una discussione; per esibirsi ed
essere ammirati; per adulare; per sedurre; per confermarsi reciprocamente di
essere d'accordo e di esser quelli della parte giusta INVECE: perchè Socrate per conoscere sé stesso dialogava con gli
altri? Per lui fare filosofia serviva ad agire utilmente nel
confronto con gli altri visto che tale confronto non si può
accettare come scontato (la socializzazione ecc) né disprezzare come
inutile (lo stoicismo ecc) : 1) esso serve a noi quando
vediamo gli altri in situazioni moralmente negative, perchè ci aiuta a
capire come tali situazioni se osserviamo realisticamente gli altri non
portino alla felicità e dunque falsifica ipotesi sbagliate di condotta
anche per noi; 2) esso serve a noi quando vediamo gli altri che adottano comportamenti e
idee ai quali noi e cioè la dotazione dei nostri a priori ristretti,
omogenei, prevedibili non avremmo pensato, ci indicano strade nuove (apriori
cioè diversi, eterogenei, imprevedibili) e aperte al cammino verso la
felicità e dunque falsificano gli apriori ristretti che negavano che quelle
strade fossero pervie.
In entrambi i casi il confronto con
gli altri ci serve come in generale serve la filosofia non per dirci cosa
fare, ma dirci cosa non fare:
nel primo caso ci dice di non comportarci come gli altri, nel secondo caso
ci dice di non mantenere (solamente) gli apriori ristretti e asfittici che
avevamo. Cerchiamo alcuni esempi sia di questi due casi buoni (confronto
ammonitore confronto liberatore sia dei due casi cattivi (il non confronto
con gli altri della autarchia stoica, e
il confronto devastante con gli altri della socializzazione
malintesa) per concretizzare il
concetto....
-
Filosofia
come scienza dei principi,
cioè dei concetti comuni alla base di ogni conoscenza: Socrate chiedeva “ti
estì” cercava il concetto ma il suo trovarlo parzialmente e provvisoriamente
gli faceva pensare di non sapere anche Platone e Aristotele cercavano il
concetto, ma il loro trovarlo
parzialmente e provvisoriamente faceva loro pensare di sapere Specificamente
quanto emerso dalla distinzione scienze/filosofia e il problema della utilità (teoretica) dei trascendentali (Collingwood chiama la
transcategorialità della
filosofia “overlapping
concepts of philosophy”
in Essay
on Philosophical Method,
1933)
-
Filosofia
come momento metodologico della storiografia
(storiografia
della mia vita singola, storiografia della mia comunità o nazione,
storiografia dell'umanità. storiografia dell'universo). Ci sono cioè DUE
livelli della filosofia: il primo quello che abbiano
appena detto (filosofia come scienze dei principi cioè dei concetti
transcategoriali che il senso comune di tutti gli uomini non può fare a
meno di usare, e che la filosofia come particolare
forma di conoscenza indaga,
critica, discute, esplicita, rende consapevoli);
il secondo livello una
sintesi che io farei tra varie indicazioni di vari filosofi: a)
il conosci te stesso di Socrate; b)
la phronesis di Aristotele, c)
l'esortazione al presente di Marco Aurelio; d) la diuturna autoanalisi di Freud; e) il problema storico nella storia come pensiero e come azione di
Croce; f) tutta la vita risolvere
problemi di Popper.
Bibliografia
-
Agostino
d'Ippona, L'utilità del credere,
410
-
Tommaso
d'Aquino, Somma teologica, 1272
-
Renée
Descartes, Discorso sul metodo,
1637
-
Voltaire,
Dizionario filosofico, 1764
-
G.W.F.
Hegel, Enciclopedia delle scienze
filosofiche in compendio, 1817
-
Karl
Marx, Per
la critica dell'economia politica, 1859
-
Friedrich
Nietzsche, Così parlò Zarathustra,
1885
-
Benedetto
Croce, Teoria e storia della
storiografia, 1915
-
Moritz
Schlick, Teoria generale della
conoscenza, 1918
-
Rudolf
Carnap, La struttura logica del mondo,
1928
-
Alfred
Rosenberg, Il mito del XX secolo,
1934
-
Karl
R. Popper, La logica della ricerca
scientifica, 1934
-
Robin
G. Collingwood, An Essay on Metaphysics, 1940
-
Herbert
Marcuse, Eros e civiltà, 1955
-
Herbert
Marcuse, L'uomo a una dimensione,
1964
-
Henri
De Lubac, Il
mistero del sovrannaturale,
1965
-
Robin
G. Collingwood, Essay on metaphysic
-
Robin
G. Collingwood, Essay on philosophical
method
-
Benedetto
Croce, Logica come scienza del
concetto puro
-
Benedetto
Croce, La storia come pensiero e come
azione
-
Sigmund
Freud , Analisi terminabile e
interminabile
-
Marco
Paolinelli, Le ragioni del filosofare
-
Sofia
Vanni Rovighi, Elementi di filosofia
vol. I
-
Robin
G. Collingwood, An
Essay on Metaphysics, 1940
-
Sofia
Vanni Rovighi, Elementi di filosofia, La Scuola Editrice, Brescia,
1962 EdF
-
Karl
R. Popper, Congetture e confutazioni, 1963
-
Marco
Paolinelli, Contro il monismo epistemologico. Filosofia e scienza nel
pensiero di Sofia Vanni Rovighi, Educatt, Milano, 2009
CME
Franco Manni indice degli scritti
Maurilio Lovatti main list of online papers